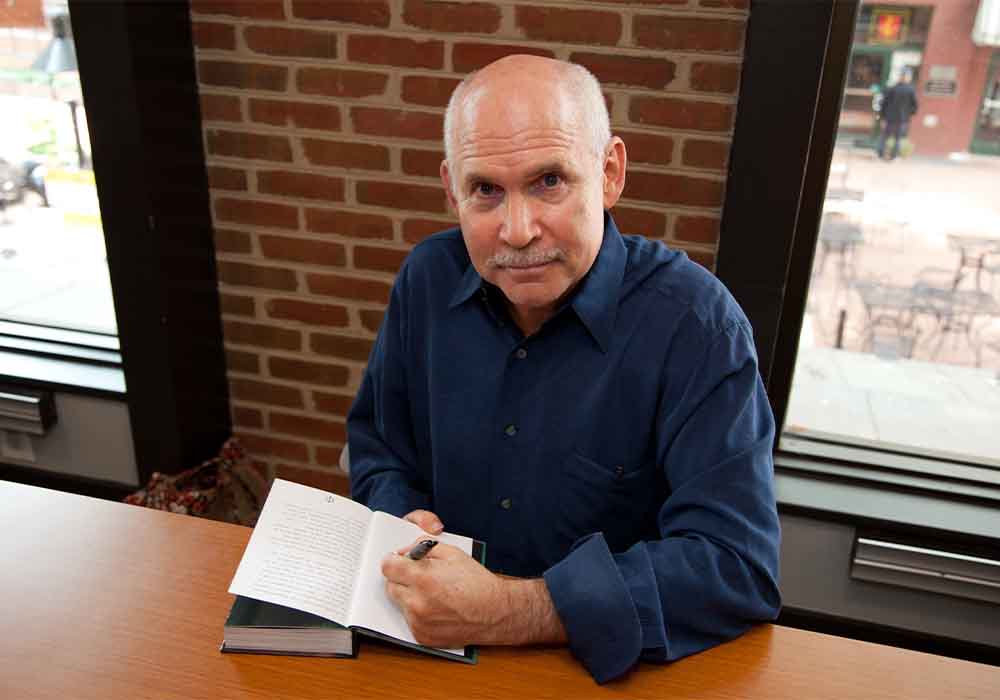Tamu è una piccola libreria gialla spuntata nel 2018 accanto al monastero di Santa Chiara, a Napoli. Una piccola libreria gialla che è fiorita sempre più negli anni: frotte di studenti, professori e appassionati la vedono ormai come un punto di riferimento per la letteratura araba e mediorientale. E non solo. Ormai, l’identità di questo luogo e di questo nome è diventata sfaccettata e si è arricchita di un nuovo progetto: Tamu Edizioni. Si tratta di un progetto culturale indipendente e collettivo, che cura e pubblica saggi e narrativa dedicati al femminismo, all’antirazzismo, alle migrazioni, alle eredità del colonialismo e alla crisi ecologica del pianeta. E non è un caso che sia nata a Napoli, punto liminale tra il Sud del mondo e l’Europa, sintesi di due culture che continuano a intrecciarsi.
Partiamo da uno dei vostri progetti più recenti: Arabpop. I media ormai ci narrano i paesi arabi su un’unica nota: il terrorismo. Guerra, arretratezza, fondamentalismo. Come se non ci fosse nient’altro. Voi avete fatto una scelta di rappresentazione estremamente diversa: una rivista di arti e letterature arabe contemporanee.
«Inizio da un aneddoto che può essere illustrativo della situazione che ci portiamo dietro da tempo. Alla fine di una presentazione che si è svolta qualche giorno fa a Roma per il lancio di Arabpop, nel momento dell’intervento del pubblico un signore si è alzato dicendo: “Se volete supportare le donne arabe, donate a questa associazione. Fatelo, perché i talebani non vogliono mandarle scuola”. Non c’è niente di male in questo tipo di intervento, però una delle collaboratrici del primo numero, ringraziando, ha commentato: “Occorre precisare che l’Afghanistan è un paese musulmano, non arabo e quindi tecnicamente quelle non sono donne arabe”. Questa è una piccola cosa, però ci parla. Grazie alle persone che stanno collaborando al progetto di questa rivista di arti e letterature contemporanee dei paesi arabi, stiamo cercando di puntare a un’informazione che eviti simili equivoci. Nonostante siano passati vent’anni dall’11 settembre 2001, il momento della costruzione della figura dell’arabo come terrorista, non riusciamo ancora a orientarci bene tra queste categorie».
Vero. Sembra che l’unica maniera di rapportarci a questo mondo sia quella paternalistica del “poverini, dobbiamo aiutarli”. I media ci mostrano le culture diverse da quella occidentale solo quando vengono oppresse: la classica immagine del bimbo africano con la pancia grossa che guarda triste la telecamera. Quando c’è cambiamento, iniziativa, protesta, non c’è la stessa attenzione mediatica. Anche le rivolte arabe sono state liquidate molto velocemente.
«Sì, esattamente. Arabpop ha molto a che fare con questo discorso, perché prima della rivista è uscito un libro, pubblicato da Mimesis, che ha messo insieme il gruppo di studiose ricercatrici che poi hanno deciso di formare una redazione per occuparsi della rivista. Il libro partiva da come si sono trasformate le culture dei paesi arabi dopo le rivoluzioni del 2011. Le rivoluzioni non come spiegazione di tutto quello che è successo dopo, ma come elemento senza il quale sicuramente non si può comprendere che cosa è cambiato e quali sono le produzioni culturali di oggi. Questa, però, è una rivista che non è pensata come strumento di studio sui paesi arabi con un punto di vista che è totalmente esterno. Tutta la prima sezione è dedicata a brani di narrativa e di poesia ancora inediti in italiano, che appunto vengono proposti in traduzione per la prima volta con un duplice scopo: quello di avere dei testi in cui sono autori/autrici dei paesi arabi a parlare e non una voce esterna, e quello di facilitare il processo di ingresso di questi materiali nella lingua italiana e, quindi, anche nella potenziale circolazione in Italia di traduzioni che potrebbero essere poi portate avanti nell’editoria.
Questo tema, quello delle trasformazioni politiche, è molto presente: per esempio, mi viene in mente uno degli articoli, un approfondimento sul festival femminista Chouftouhonna, che si svolge a Tunisi. È un momento di forte presa di parola dall’interno delle donne tunisine, ma anche delle persone non binarie e delle soggettività queer. È un racconto di come questo festival si è inserito nel contesto culturale del paese. Mi viene anche in mente una parte monografica molto bella, proprio al centro della rivista, tutta dedicata a Beirut. L’esplosione del porto dello scorso anno ha cambiato completamente il volto della città, ma ha anche inciso sulla nascita di movimenti di protesta molto forti. Ritorna l’idea che le rivoluzioni arabe non sono la cosa iniziata e finita nel 2011, di cui si commenta soltanto l’esito negativo. Tra il 2000 e il 2019 ci sono stati tanti movimenti di protesta, qualche traccia è rimasta».
Il tema del primo numero di Arabpop è la metamorfosi. È legato a questo discorso, quindi?
«Sì, ma senza dare all’aspetto dei movimenti politici un ruolo esclusivo in questa metamorfosi. La lente di osservazione della rivista sono le produzioni culturali e siamo molto contenti che in questo primo numero ci siano veramente tanti linguaggi diversi: c’è il fumetto, c’è una rubrica musicale con consigli di dischi, articoli dedicati al cinema, all’editoria, alle arti visive. Il motivo per cui si è scelta questa chiave è privilegiare non solo lo studio delle culture dei paesi arabi, ma l’aspetto pop. Ci sono questi due elementi nel titolo della rivista che sono entrambi importanti. In redazione, diamo tutti significato diverso a cosa vuol dire arabo e cosa vuol dire pop. Io in questo momento ti direi che pop significa non esotico, qualcosa che fa parte della cultura contemporanea mainstream. La rivista non si rivolge soltanto a studiosi specialisti dei paesi arabi, ma a chiunque sia appassionato di arti in genere. E, ovviamente, un po’ di curiosità per culture non europee non guasta».
Quel bel rosa shocking in copertina comunica proprio questa scelta…
«La veste grafica della rivista è pensata per presentare un oggetto che non sia necessariamente di nicchia, non appunto solo uno strumento di studio, ma anche un modo per trovare un disco da ascoltare o andare a cercare un film interessante».
Mi dicevi prima della rubrica musicale. Sembra davvero interessante…
«La rubrica musicale contiene esclusivamente musica elettronica. Che non è qualcosa che generalmente si tende ad associare al mondo arabo, ma a Londra o Berlino. Questa scelta vuole proprio deviare l’attenzione da ciò che solitamente è percepito come arabo o legato alle culture tradizionali del Sud globale. È importante dare risalto a questa scena, ma non perché si tratta di musica elettronica certificata araba. Ovviamente, il contesto culturale in cui viene prodotta è un contesto arabo, ma ciò non deve necessariamente trasparire dal suono stesso. In alcuni casi succede, però. Nella rivista c’è un articolo dedicato a un gruppo hip-hop tunisino che ha avuto un successo clamoroso per il fatto di aver ripreso basi tradizionali che si trasformano in pezzi hip-pop/rap».
Puoi darci qualche spoiler sui temi dei prossimi numeri?
«Non posso, e ora ti spiego perché. La costruzione della rivista avviene in maniera particolare. Ci sono due gruppi distinti. Tamu Edizioni si occupa di tutto ciò che non è la redazione: ufficio stampa, diffusione, diritti. La selezione dei testi, invece, viene curata da un gruppo di redattrici. Il legame più esplicito con noi come casa editrice e la rivista è la grafica: il nostro grafico è anche quello di Arabpop. Per il primo numero, c’è stata una chiamata in più lingue. Ci si è rivolti a un panorama non solo di studiosi dei paesi arabi, ma anche di disegnatori, autrici arabofoni o arabi. Ciò ha fatto sì che affluissero in questo numero anche i contributi proposti dagli autori. E la stessa cosa avverrà per il secondo numero: la call arriverà a breve, tra un mese, la rivista invece uscirà a marzo».
Oltre alla grafica direi che ci sono altri collegamenti con la vostra casa editrice: state facendo un lavoro molto particolare relativo al Sud del mondo e anche qui ho visto che cercate di privilegiare l’auto-rappresentazione delle varie culture – un aspetto al quale teniamo molto anche noi di Mar dei Sargassi – e la metamorfosi.
«Sì, assolutamente. Ti faccio degli esempi sui libri che sono usciti finora. Forse vale la pena concentrarsi sul fatto che tre dei cinque saggi che abbiamo pubblicato sono riferibili alla cultura nera statunitense. Li abbiamo scelti tra tanti altri per una possibilità di traduzione nel contesto culturale e politico italiano. Non per una volontà di approfondire semplicemente un oggetto di studio come può essere tutta la mobilitazione politica antirazzista degli Stati Uniti. Ma perché libri come Elogio del margine – Scrivere al buio o Perdi la madre parlano della scomposizione di un’identità di appartenenza, razziale o alla nazione. Questo è molto utile per capire tutte le sfaccettature della società in cui viviamo. Le migrazioni internazionali non sono per niente un fenomeno recente come lo si vorrebbe rappresentare, ma datano almeno cinquant’anni in Italia. E le migrazioni hanno prodotto una società non solo bianca, ma dove l’identità personale può essere una cosa molto complessa. Dobbiamo fornirci di strumenti per capire questa complessità».
Hai accennato a Perdi la madre, la vostra ultima pubblicazione. Me la racconteresti?
Perdi la madre è un libro estremamente appassionante, quasi un romanzo. In realtà, nasce come ricerca storica sulla tratta degli schiavi tra l’Africa occidentale e gli Stati Uniti. È la storia di un continuo fallimento nella ricerca di un’origine. Mettere in scena il rapporto tra un mondo nuovo, gli Stati Uniti di oggi, e un’ipotetica origine, l’Africa. Nel libro questa ricerca di un’origine viene continuamente messa in discussione dagli incontri che l’autrice-narratrice fa in un viaggio attraverso il Ghana, nei luoghi che quattro secoli fa erano di passaggio del commercio di schiavi. C’è un tratto estremamente forte in cui un personaggio spiega alla narratrice che se oggi una nave negriera attraccasse al porto della costa del Ghana, a centinaia si getterebbero per salire. In questo passaggio temporale tra passato e presente ci sono dei percorsi identitari molto complicati, però anche belli da seguire e appassionanti».
Per concludere, vorrei chiederti un consiglio di lettura, ma su un tema preciso. Con LIRe, la rete di librerie indipendenti di cui fate parte, state portando in piazza un discorso su un “nuovo abitare” gli spazi pubblici. Un discorso nato da un’ormai famosa disputa con l’Amministrazione che è diventato molto di più. Cosa mi suggeriresti?
«Under Commons di Stefano Harney e Fred Moten. È un libro di filosofia politica, che ha una sua lingua molto articolata e metaforica. Oltre a essere un saggio teorico, ha anche una dimensione quasi poetica nel modo di esporre i concetti. Si concentra molto sulla definizione di cosa è pubblico e cosa è privato. Una delle chiavi di lettura è una sorta di disarticolazione del privato e del pubblico da quello che generalmente intendiamo con questi due termini. La società in cui viviamo oggi ci mostra spesso come pubblico sia qualcosa che in realtà non lo è: pensiamo appunto alla questione dello spazio urbano in cui il pubblico viene continuamente mercificato. Il discorso di Under Commons, però, non è semplicemente una constatazione del fatto che questo spazio si stia riducendo. Il discorso è più interessante: i due autori sono convinti che una forma pubblica di cultura, di interazione, di socialità, sopravviva all’interno di qualsiasi contesto, che sia il contesto che nominalmente viene dichiarato pubblico, che sia quello che viene considerato privato. Quindi, quello da cui ci dobbiamo difendere è la svendita sul mercato della nostra capacità di incontrarci, socializzare, fare, proporre una forma di cultura. Possiamo ricreare una situazione pubblica in ogni contesto. È quello che stiamo cercando di fare con le presentazioni dei libri, anche se a volte ci troviamo a star lì seduti sui tavolini dei bar perché sono diventati l’unico posto dove si può stare insieme all’aria aperta. Allora troviamo in questo margine, in questa contraddizione, una situazione che in realtà è pubblica. E che lo è non tanto perché c’è un qualcosa che la certifichi come tale, ma perché nel momento in cui ci incontriamo per un’assemblea sul diritto alla città o per la presentazione di un libro, stiamo facendo qualcosa che in parte sfugge alla logica di mercato».