Nell’anno appena trascorso, confinati tra le mura domestiche, braccati dall’infodemia, rieducati a un nuovo alfabeto del vivere sociale fatto di distanze, videoconferenze, mascherine e gel igienizzanti, sono stati i libri a raccogliere i cocci delle nostre individualità disorientate. Quelli ambientati lontano nel tempo, nello spazio, in vasti mondi di fantasia in cui uomini e donne compiono gesta eroiche alla ricerca di qualche manufatto magico per salvare la propria terra dalla rovina. Allo stesso tempo, nella lotta alla COVID-19, sono confluiti gli elementi narrativi del fantastico.
Nell’era dello storytelling, la pandemia ha assunto i contorni di un’epica: i giornalisti e i politici, trasformati in bardi, hanno preso in prestito manciate di vocaboli dal repertorio del fantasy e questa parte del mondo si è popolata di eroi, saggi, nemici inafferrabili da annientare, cure salvifiche come magia che attraversano simbolicamente il paese la notte di Natale. Forse, abbiamo dovuto raccontarci così questa storia per renderla più digeribile, per stabilire un distacco dall’orrore e rimanere sani. Forse, attribuire nomi diversi, fantastici, alle cose funziona per astrarre le responsabilità dal contesto, per posporre le doverose discussioni sull’ordine distorto della realtà. Fatto sta che rifugiarsi in mondi immaginari resta la nostra più antica forma di cura, il modo più umano di affrontare le avversità della storia.
I grandi romanzi dell’epica fantastica dello scorso secolo, Il Signore degli Anelli e Le cronache di Narnia, portano le tracce dei conflitti mondiali e la ricerca di senso – spesso anche spirituale – di un’umanità devastata dalla guerra, di un mondo che doveva fare i conti con il rivoluzionario progresso tecnologico e con la ricostruzione post-bellica. Nel suo saggio sul fantastico – On Fairy-stories, che raccoglie l’intervento dello scrittore alla St. Andrews University –, Tolkien sostiene che, qualunque sia l’intento del narrare, le storie finiscono inevitabilmente per manifestare e proiettare nel mondo fiabesco il più grande desiderio dell’uomo: quello della grande fuga dalla morte. E questa fuga può attuarsi solamente per un tramite magico. Potremmo azzardare, continuando a seguire le indicazioni del celebre scrittore, che non ci sia nulla di più magico delle parole, che hanno il potere di fare e disfare le cose, scolpire interi universi e raderli al suolo. Già l’arte (magica) del Prospero di Shakespeare altro non era che parola messa in scena in quell’esperimento di teatro nel teatro che è La tempesta. D’altro canto, lo stesso Tolkien conclude che il confine tra realtà osservabile e verità del fantasy sta nella capacità del narratore di evocare quel mondo e le creature che lo popolano.
E ne Le cronache di Narnia (C. S. Lewis) o La Storia Infinita (Micheal Ende) la genesi di mondi fantastici non avviene, forse – con un chiaro riferimento alla Creazione biblica – a partire dal canto, dalle parole? Il fantastico ci strappa alla paura perché genera in noi il germoglio dello stupore e la meraviglia dell’inesplorato, ci culla in una litania immortale che rivive a nostro uso e consumo ogni volta che apriamo un libro e partecipiamo della sua magia. Susanna Clarke, discepola per propria stessa ammissione di Tolkien e Lewis, racconta alla perfezione questo legame fitto e misterioso con il fantastico nel suo nuovo romanzo: Piranesi, in uscita per Fazi Editore il prossimo 4 febbraio.
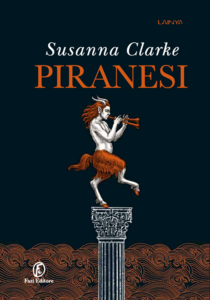 Ambientato in un’immensa casa-labirinto, si presta particolarmente bene anche a una lettura estremamente attuale, che faccia i conti con le diramazioni delle nostre angosce e il nostro mutato rapporto con l’ambiente domestico. Piranesi, però, non è stato concepito in tempi di pandemia. Sopraffatta dal successo internazionale del suo romanzo d’esordio, Jonathan Strange e il Signor Norrell, Clarke è caduta vittima di un male dell’animo paralizzante e debilitante che l’ha, poco a poco, portata a vivere in auto-isolamento. La casa e la mente sono luoghi sicuri che possono diventare prigioni, come abbiamo avuto modo di sperimentare a livello globale sulla nostra pelle nel corso del 2020. Il protagonista del romanzo non ha nome, non ha storia, è l’unico essere umano vivente di questo mondo fatato chiamato semplicemente Casa. I piani inferiori sono bagnati da acque salmastre, le correnti marine ne hanno inondato intere sezioni e sono, ora, dimora solo dei pesci; i piani superiori sono attraversati dalle nuvole e dai venti; dalle finestre si vedono gli astri. Non vi sono arredi, ma statue raffiguranti concetti e situazioni che nella realtà della Casa non trovano riscontro, come quella che rappresenta un giardino o quella della donna che regge un alveare. Sulle statue si appollaiano gli uccelli con i quali il protagonista trova un raro senso di comunione.
Ambientato in un’immensa casa-labirinto, si presta particolarmente bene anche a una lettura estremamente attuale, che faccia i conti con le diramazioni delle nostre angosce e il nostro mutato rapporto con l’ambiente domestico. Piranesi, però, non è stato concepito in tempi di pandemia. Sopraffatta dal successo internazionale del suo romanzo d’esordio, Jonathan Strange e il Signor Norrell, Clarke è caduta vittima di un male dell’animo paralizzante e debilitante che l’ha, poco a poco, portata a vivere in auto-isolamento. La casa e la mente sono luoghi sicuri che possono diventare prigioni, come abbiamo avuto modo di sperimentare a livello globale sulla nostra pelle nel corso del 2020. Il protagonista del romanzo non ha nome, non ha storia, è l’unico essere umano vivente di questo mondo fatato chiamato semplicemente Casa. I piani inferiori sono bagnati da acque salmastre, le correnti marine ne hanno inondato intere sezioni e sono, ora, dimora solo dei pesci; i piani superiori sono attraversati dalle nuvole e dai venti; dalle finestre si vedono gli astri. Non vi sono arredi, ma statue raffiguranti concetti e situazioni che nella realtà della Casa non trovano riscontro, come quella che rappresenta un giardino o quella della donna che regge un alveare. Sulle statue si appollaiano gli uccelli con i quali il protagonista trova un raro senso di comunione.
Come un Robinson Crusoe naufragato in un altro mondo, il personaggio senza nome tiene un diario che riporta alla mente del lettore il filone della narrativa di viaggio, così in voga proprio negli anni in cui Daniel Defoe pubblicava il suo capolavoro. Apprendiamo dalle sue pagine che nella Casa è presente un Altro individuo, il quale, per celia, affibbia al protagonista il nome di Piranesi, quello di un celebre architetto italiano. Giovanni Battista Piranesi è vissuto nel Settecento ed è noto soprattutto per alcune sue tavole intitolate Carceri d’invenzione, nelle quali raffigurava architetture fantastiche senza inizio né fine, labirintiche, ingannatrici. All’estero, il fascino delle Carceri ha influenzato il grande narratore del gotico inglese Horace Walpole tanto da fornire suggestioni per il suo Castello di Otranto. L’abile saggista Thomas De Quincy, in Confessioni di un fumatore d’oppio, paragonò le allucinazioni e i sogni generati su di sé dalla droga alle illustrazioni visionarie di Piranesi. Nella biografia dell’architetto a cura di Marguerite Yourcenar, la scrittrice racconta che Piranesi lavorò alle Carceri dopo essere stato affetto da malaria, nel 1742: la febbre, anziché il delirio, aprì all’artista le porte di un mondo amplissimo e più complesso di quello in cui aveva vissuto da sano, anche se fatto, in sostanza, della stessa materia. E quella materia è artificiale perché Piranesi vedeva, nei monumenti della classicità (soprattutto romana), un nuovo ordine che si mescolava perfettamente alla natura. Con l’architetto Piranesi, Clarke condivide l’abilità di trasformare la passione della malattia in creazione. Anzi, forse, proprio nella sofferenza, la magia creativa dell’artista si rafforza nell’impeto di fuga dall’oblio della fine.
Il labirinto del libro è una versione onirica, una dimensione extra-spaziale delle opere dell’uomo che ci circondano. Del sogno conserva, come nota Yourcenar, la negazione del tempo, la dilatazione e l’incoerenza degli spazi, l’irrazionale, il terrore estatico, una bellezza fatale. Sebbene si parli di sogni, è impressionante pensare a quanto bene si applichino queste caratteristiche al senso d’alienazione fluttuante e sonnolento che abbiamo vissuto in lockdown, sospesi nel tempo, sospesi tra l’ambiente domestico e l’etere digitale, abbacinati dalla bellezza spettrale delle città vuote. Come ogni sogno che si rispetti, il fantastico di Clarke si popola di simboli: niente è semplicemente ciò che appare.
All’inizio del romanzo viene riportata una citazione dal primo libro de Le cronache di Narnia (Il nipote del Mago) e uno dei personaggi reca proprio il cognome del mago: Ketterley. Non fatichiamo a vedere in Clarke, almeno in parte, lo stesso sforzo simbolico di Lewis, soprattutto alla luce dell’entusiasta fervore religioso dell’autrice, divenuta anglicana proprio mentre affrontava la malattia. Laddove Narnia è una metafora della cristianità, Piranesi potrebbe sembrare una sorta di Giardino dell’Eden a rovescio. Qui, Adamo resiste alle tentazioni, non vacilla dinanzi a esse, non brama nulla per sé né ambisce al potere. È un grato osservatore dello spettacolo che la Casa gli offre e tanto gli basta. Pur essendo consapevole dei propri disagi, è serafico, felice. Ha fede. Il protagonista di questa fiaba non è un eroe nel puro senso del termine poiché all’azione preferisce la contemplazione. Il suo atto “eroico” è non cedere alla tentazione di privare il labirinto del suo mistero, non spogliare la Casa della conoscenza, ma godere puramente della sua maestosità. Ancora in comune con la Narnia di Lewis, Piranesi rappresenta una dimensione del possibile ed è, come tale, metafora del potere magico della letteratura. Ciascuna statua recante un concetto porta in sé anche la scintilla di una storia condensata nella pietra, quasi fosse ferma sulla punta della lingua (o della penna) di qualcuno un attimo prima di essere raccontata.
Se in Narnia il leone Aslan rappresenta Cristo, in Piranesi scorgiamo il divino nell’arrivo di un albatro. La prima visione dell’albatro che si offre al protagonista è, infatti, una lama di luce cruciforme. Il bianco delle sue piume simboleggia la purezza, l’ingenuità del nostro protagonista felice prigioniero. La croce, poi, è simbolo della Resurrezione, della sconfitta della morte. Del resto, in un luogo in cui spazio e tempo sono dilatati e distorti, la morte è una parte dell’equazione che può essere sovvertita, è un concetto spoglio dell’urgenza della paura. Nella Rhyme of the Ancient Mariner di Coleridge, l’albatro funge da guida per i marinai e fa da metafora del Cristo redentore dei peccati. L’arrivo dell’albatro in Piranesi è, di fatto, un presagio del cambiamento delle sorti del protagonista. Da questo momento in poi, una serie di inneschi ricchi di suspense trasformano la plasticità simbolica del romanzo, il suo indugiare fuori dal tempo in una narrazione dal ritmo incalzante.
Più il racconto si arricchisce di elementi, di testimonianze, di risposte più la dimensione del sogno evapora. Resta, alla fine della lettura, la sensazione di aver calcato i pavimenti della Casa come in preda a una trance la cui dolcezza, però, non riusciamo a cogliere da svegli senza che un brivido freddo ci attraversi la schiena. Se, infatti, l’albatro simboleggia il ritrovamento del giusto sentiero, la via d’uscita dal labirinto, dobbiamo allora vedere la Casa/Eden come un miraggio, un’illusione, la lanterna che attrae la falena: è un’insidia, non la salvezza. La tentazione di perdersi nel regno del possibile, nel sogno, e diventare schiavo del sortilegio in cambio della promessa della vita nel dedalo delle ossessioni. Questa interpretazione risulta tanto più credibile quanto più prestiamo attenzione alla vicenda personale di Clarke, alla sua storia di auto-isolamento. Quest’insidia risulta tanto più vicina al contesto della pandemia, che continua a gravare sulla salute mentale di milioni di individui, ricacciandoli a forza in un isolamento fisico e psicologico che può trasformarsi in labirinto.
Prendete la lettura di Piranesi o della letteratura del fantastico come il rimedio magico a un male invisibile: una pozione per affrontare la paura della malattia e della morte e ritrovare il cammino verso la speranza.









