C’è una funzione, su Spotify, che permette di ripercorrere il proprio anno in brani riprodotti. I social si popolano per gioco degli screenshot con le statistiche personali: un altro frammento delle nostre personalità multiformi condiviso in rete, esposto allo scopo di rientrare in una categoria, di ricercare una definizione di noi stessi e, in quella definizione, trovare affinità con gli invisibili che ci osservano all’altro capo dello schermo. Quel che colpisce di questa particolare performance online è la tendenza con la quale tanti manifestano vergogna e distanza dalle proprie statistiche.
Come strumento di aggregazione sociale, la musica che ascoltiamo in gruppo determina spesso come vogliamo che questo ci veda, gli amici che ci piace frequentare, il modo in cui vogliamo essere percepiti. Associamo ai generi musicali caratteristiche e qualità personali mai veramente neutre: se il nostro palato è abbastanza sofisticato tendiamo a sentirci persino migliori degli altri, di quelli che ascoltano roba commerciale, ad esempio. Oggi, però, la musica è anche e soprattutto voluttà esperita in privato, al riparo da orecchie indiscrete, il suono rotondo ed ermetico sparato in cuffia direttamente al cervello. È un ascolto esplorativo, libero dalla necessità di collocarsi in una categoria, libero dalla paura dell’altrui giudizio. Così, con il mondo esterno ovattato dagli auricolari, siamo noi stessi nella forma più pura perché non sentiamo il bisogno di appartenere a null’altro se non alle note. Le statistiche di Spotify, in definitiva, ci deludono perché ci smascherano.
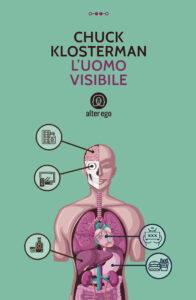 Il protagonista del romanzo de L’uomo visibile di Chuck Klosterman (Alter Ego) è ossessionato dalla separazione tra vita pubblica e privata, dal vero che trasudano i corpi nel chiuso di case che abitano da soli. La sua teoria è che, strizzati nei contesti sociali, siamo tutti invisibili, irrilevanti. Quando siamo soli, invece, è come se indossassimo una pelle nuova, tenera e vulnerabile ma perfettamente visibile. Una pelle che reca tatuato il codice sorgente della nostra personalità. Per osservare indisturbato l’umano isolato, il misterioso personaggio mette a punto un dispositivo che rifrange la luce in modo da creare l’illusione ottica della sua assenza. Il dispositivo, composto da una tuta e da una crema, è di derivazione dichiaratamente fantascientifica: è stato creato sul modello di uno strumento analogo presente in un famoso romanzo di Philip K. Dick, Un oscuro scrutare. Indossandolo, l’individuo di Klosterman diventa, di fatto, impossibile da vedere (guai, però, a chiamarlo uomo invisibile).
Il protagonista del romanzo de L’uomo visibile di Chuck Klosterman (Alter Ego) è ossessionato dalla separazione tra vita pubblica e privata, dal vero che trasudano i corpi nel chiuso di case che abitano da soli. La sua teoria è che, strizzati nei contesti sociali, siamo tutti invisibili, irrilevanti. Quando siamo soli, invece, è come se indossassimo una pelle nuova, tenera e vulnerabile ma perfettamente visibile. Una pelle che reca tatuato il codice sorgente della nostra personalità. Per osservare indisturbato l’umano isolato, il misterioso personaggio mette a punto un dispositivo che rifrange la luce in modo da creare l’illusione ottica della sua assenza. Il dispositivo, composto da una tuta e da una crema, è di derivazione dichiaratamente fantascientifica: è stato creato sul modello di uno strumento analogo presente in un famoso romanzo di Philip K. Dick, Un oscuro scrutare. Indossandolo, l’individuo di Klosterman diventa, di fatto, impossibile da vedere (guai, però, a chiamarlo uomo invisibile).
Osservate decine di soggetti in anni di studio, l’uomo non-visibile decide di rivolgersi a una psicologa, Vicky Vick, per dare senso alla sua ricerca scientifica e liberarsi del senso di colpa. A tramandare il racconto di questo bizzarro paziente sarà proprio la psicologa: il romanzo è in realtà un esperimento metanarrativo, che si compone delle bozze scorporate del libro-testimonianza scritto da Vicky e venduto a un editore per la pubblicazione. Le bozze contengono continue intromissioni della narratrice/autrice, ammettono omissioni, si compongono per lo più di trascrizioni di conversazioni con Y_____ (il vero nome dell’uomo non-visibile viene celato) somiglianti a soliloqui veri e propri.
Il libro di Klosterman è sardonico fin dalle prime battute: Y_____ cerca evidenza scientifica per la sua tesi minando la condizione principe dell’esperimento, la solitudine, con la sua presenza invisibile; il romanzo, che si interroga dunque sulle sfaccettature dell’individualità, è esso stesso sfaccettato, mai uguale in ogni sua parte. Il ritmo della narrazione risente parzialmente di questo, fatica a ingranare pur facendo ampiamente affidamento alla suspense. La sociopatia di Y___, il modo in cui prova machiavellicamente a manipolare Victoria, la sua incapacità di pietà e la sua condizione quasi superomistica sono indizi inequivocabili di un evolvere malsano dell’intera vicenda. Le dinamiche tra i due protagonisti ricordano vagamente il film Split di M. Night Shyamalan ma, purtroppo, non ne replicano sempre la tensione.
Klosterman viene dal giornalismo, è principalmente un autore di saggistica e il suo campo è la cultura pop in tutte le sue declinazioni. Privo di quello snobismo che spesso avvolge come un vestito aderente la professione di critico, lo scrittore è tra coloro che hanno scorto, nell’estremismo perfomativo, nelle esagerazioni pirotecniche della tv dei reality, dei serial, delle sottoculture musicali, del mondo dello sport, un terreno fertile per l’indagine della nostra modernità. L’uomo visibile è pertanto intriso di cultura pop: dal chiaro riferimento al famosissimo romanzo di Wells (L’uomo invisibile), al sopracitato Philip Dick, al nome della psicologa di ispirazione quasi tarantiniana. Lo scrittore cita apertamente i Soprano e allude alla serie cult LOST.
I soggetti dell’esperimento di Y_____ non esistono in una bolla: si muovono in un mondo che è stato anche il nostro, quello del 2008, in cui i social network muovevano i primi passi (solamente Facebook e Goodreads vengono citati) e Netflix spediva i dvd a casa su ordinazione mandando a gambe all’aria il colosso Blockbuster. Il romanzo, uscito nel 2011, è però talmente radicato alla cultura pop di quegli anni da risultare purtroppo già anacronistico dopo appena un decennio. L’evoluzione tecnologica non ci avrà portato a sviluppare tute che ci rendono invisibili per permetterci di spiare gli altri, ma gli smartphone dai quali siamo diventati inseparabili agiscono costantemente da finestra sui loro mondi privati. Una fetta consistente di internet si nutre contemporaneamente di voyeurismo e narcisismo, trasformando quella che altrimenti chiameremmo banalità quotidiana in contenuto fruibile in rete. Pur suggerendo molto sottilmente una simile deriva, a L’uomo visibile di Klosterman manca quell’elemento di universalità che ha reso grande l’opera di Wells, pubblicata per la prima volta nel 1897.
Nelle storture del mondo attraverso gli occhi del paziente Y____ ci riconosciamo senza dubbio, ma è come guardare una nostra vecchia fotografia al liceo con la consapevolezza che tanto è cambiato. Forse, la differenza sta nel fatto che Y____ ha la presunzione di dirsi imparziale osservatore mentre nella tragedia del Griffin di Wells siamo messi di fronte alla fragilità delle ambizioni umane. L’impatto che L’uomo invisibile ha avuto proprio sulla cultura pop è innegabile: è diventato un tropo sfruttato e declinato dall’industria cinematografica, ampliato e scandagliato nelle opere a fumetti. Per ovvi motivi, Y___ non può che esserne una deriva a sua volta. Deriva che si palesa chiara nel delirio di onnipotenza dell’uomo non-visibile, la cui condizione sembra sollevarlo dell’umanità ed elevarlo, almeno secondo la sua percezione, a entità superiore capace di giudicare la pateticità dei soggetti osservati e intervenire come deus ex machina nelle loro vite. È in questo aspetto che la critica di Klosterman si fa più feroce, regalandoci le riflessioni più belle del romanzo: Y___, nel suo lavoro di osservatore, si comporta esattamente come facciamo noi dinanzi ai personaggi di un reality show. Saziamo la nostra curiosità guardando le persone fingere di essere sole, fingere di umiliarsi trascinandosi nel patetismo di giorni che trascorrono sempre uguali e, quando ci hanno stufato, cambiamo canale o esercitiamo il nostro potere di spettatori votando perché siano eliminate dal programma.
Per Klosterman, i reality show si compongono di più livelli di realtà: si parte dall’idea che ciò che vediamo sia reale, nonostante tutti a casa sappiamo che si tratta di intrattenimento costruito a tavolino. Poi però c’è un altro livello, in cui da una realtà simulata ne emerge una fattuale. E le relazioni fasulle diventano vere. Dopo ancora c’è un terzo livello, quello della realtà accettata, in cui il fintume generale finisce per somigliare alla realtà effettiva più di quanto gli ideatori del programma avessero previsto inizialmente.
Questa riflessione non solo è ancora valida adesso, ma assume un significato nuovo quando la trasliamo all’ambito del privato simulato sui social cui facevamo riferimento. I livelli di realtà e finzione sono talmente intrecciati che il rischio di perdersi in un caleidoscopio di rappresentazioni di sé è concreto. Cercare di distinguere tra i gradi di purezza delle manifestazioni della nostra personalità porta a considerarci mai integri: individui composti da frammenti di maschere sempre diverse a seconda del contesto, a seconda degli stimoli che riceviamo dall’esterno. La pretesa che esista un io corrispondente al vero più della somma delle sue performance ci spinge alla ricerca spasmodica di questa verità, al tentativo di ricucire insieme i pezzi in un unicum coeso la cui appartenenza ci soddisfi. E, dunque, più ci sentiamo frammentari, più ci ostiniamo a fissarci su una definizione che sta fuori da noi.
Nel corso del suo esperimento Y_____ è più volte affascinato testimone del ruolo giocato dalla musica nel definire chi siamo. C’è un intero episodio che ruota intorno a un gruppo di persone ribattezzate i tizi pesanti che ascoltano heavy metal, si somigliano tutti e sono un’accozzaglia dei più brutti stereotipi sui metallari mai concepiti da mente umana. In questo aneddoto, Klosterman ironizza sull’aridità dell’omologazione, che scolora le identità. È infatti attraverso il rituale di ascoltare la musica solo per noi stessi che la nostra vera natura si manifesta agli occhi quasi invisibili di Y____. La musica ballata a tutto volume in camera da adolescenti, quella cantata davanti allo specchio imitando le movenze di una rockstar, la musica che gira sul piatto del disco mentre pensiamo alle occasioni perdute, al cuore in frantumi, all’ignoto. La musica che placa l’anima in tumulto e la ristora. La musica scrigno di ricordi eternamente felici. La forza invisibile grazie alla quale diventiamo visibili a noi stessi per davvero.








