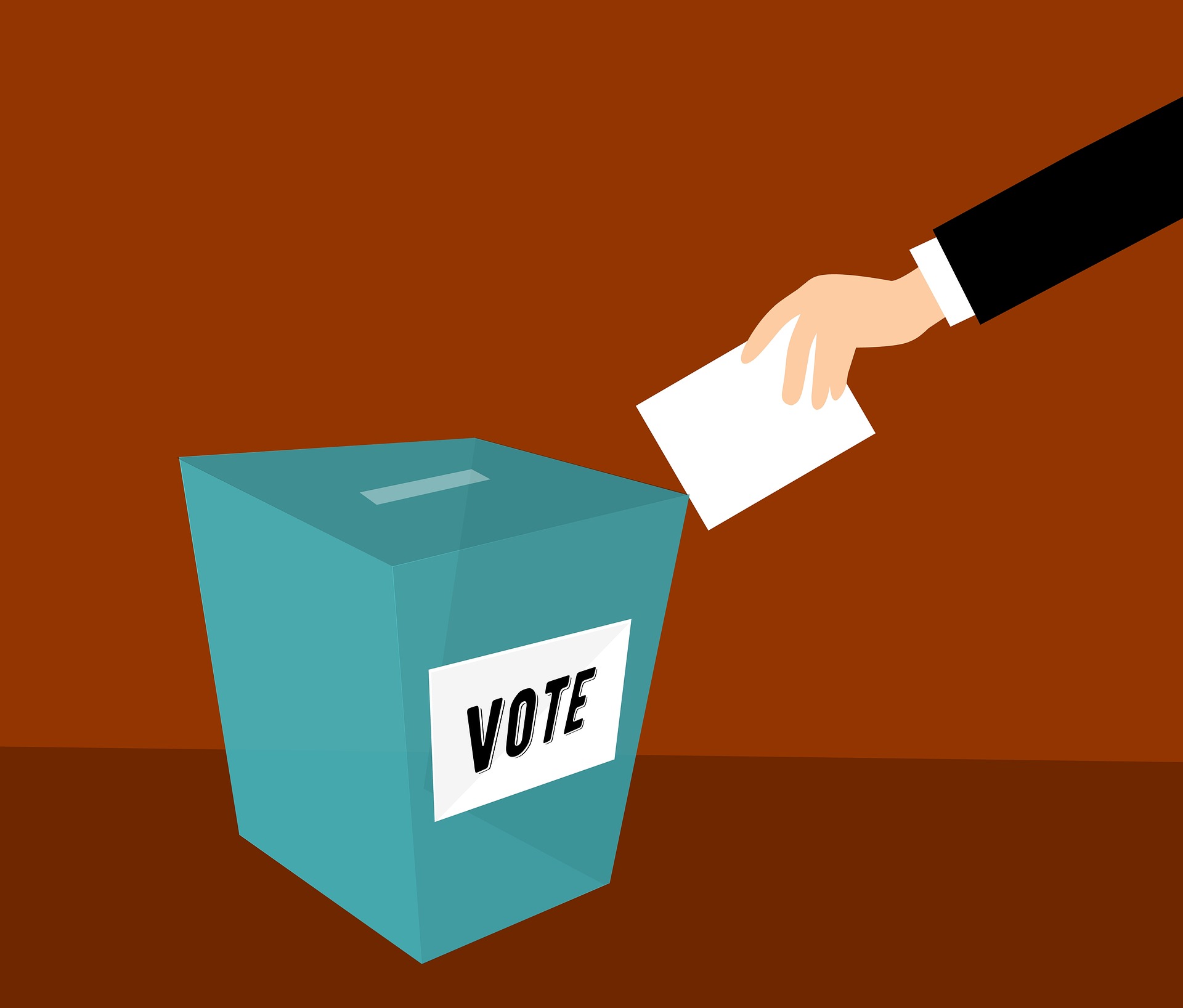Jón Kalman Stefánsson, nato a Reykjavík nel 1963, si è affacciato al mondo delle storie prima come insegnante e bibliotecario, poi attraverso le profondità della poesia per esprimere la sua voce più matura nella prosa. Giunto in Italia grazie alla casa editrice Iperborea, ha pubblicato, tra i vari, Luce d’estate ed è subito notte, Paradiso e inferno, I pesci non hanno gambe, La storia di Asta, Crepitio di stelle, La tua assenza è tenebra e le raccolte poetiche La prima volta che il dolore mi salvò la vita e Quando i diavoli si svegliano dei.
Titolo dopo titolo, senza fretta e senza tregua, traduce la vita, interrogandosi costantemente sul suo senso e su quello della morte, richiamando entrambe con grande potere evocativo. Nel 2005 ha vinto il Premio Letterario Islandese. È stato nominato più volte al Premio del Consiglio Nordico.
La sua scrittura poetica è una preghiera laica all’universo, a ogni universo contemplabile, a ogni domanda, e riesce, con eleganza e saggezza, a cogliere ciò che non comprende. Al Salone del Libro di Torino lo abbiamo intervistato in merito al suo ultimo romanzo, Il mio sottomarino giallo, ma non solo.
La sua scrittura è densa di contrasti – penso a Luce d’estate, uno dei miei libri preferiti – ma questi non stridono, ogni apparente disarmonia diventa armonica. Come riesce a compiere questo movimento con disinvoltura?
«Non c’è una vera risposta, non penso preventivamente a come faccio le cose e perché vengono fuori in un certo modo. È qualcosa che succede mentre scrivo, come comporre una canzone, il linguaggio e la scrittura sono strumenti. Ciò che hai descritto molto bene coincide con il motivo per cui scrivo: ascolto il ritmo dentro di me, le vibrazioni di una storia».
Il tempo, un elemento protagonista dei suoi romanzi, è tangibile, eppure sembra non esistere. Cos’è per Lei?
«Questa è un’altra ottima domanda. Credo di aver letto un libro una volta, si intitolava Cos’è il tempo?, che riportava anche delle evidenze scientifiche, aveva ottimi argomenti, e in conclusione… il tempo non esiste. Personalmente, ne sono sempre stato affascinato. Il tempo è tutto, il tempo trattiene ogni cosa con sé e, al contempo, te la dona. Credo che, quando l’uomo ha cominciato a pensare al tempo, quello sia stato il momento in cui ha iniziato a credere in Dio, perché quando realizza della sua esistenza si rende conto che morirà e tutto passerà. Talvolta mi capita di pensare che il tempo e Dio siano la stessa cosa. L’uomo sostiene che Dio sia eterno, ma non sa cosa sia l’eternità, non ne ha prova. Una delle ragioni per cui scrivo è capire cosa è il tempo, capire e descrivere cosa il tempo è in grado di farci, in che misura influisce sulla nostra vita. Mentirei se dicessi che non tenti anch’io di fermarlo».
Nessuno può camminare sul mare, è per questo che i pesci non hanno gambe. Scrivere è per Lei un tentativo di sovvertire questa sua stessa frase e riuscirci?
«Per quanto ne sappiamo, c’è stato un tizio che vi è riuscito. Ma anche quella è soltanto una storia, non conosciamo la verità. Scrivere, per me, è come per Faulkner, ossia fare cose impossibili. Quindi sì, non l’avevo mai vista così, ma funziona. Se riesci a maneggiare la forma, il linguaggio, a creare situazioni, assomiglia a creare un mondo».
In parte ha già risposto a questa domanda, ma magari ha voglia di aggiungere qualcosa. Ne La storia di Asta ha scritto: Tutto finisce, eppure continua. Cos’è, una sentenza implacabile o una radiosa speranza?
«Da quando ho memoria, da quando da bambino ho realizzato che gli esseri umani muoiono, ho anche avuto contezza del fatto che svaniscono del tutto. Come dici, è implacabile. Tutto ciò che appartiene loro, i libri, gli oggetti restano, ma le persone vanno, non potrai più nemmeno parlare con loro. Da bambino pensavo fosse profondamente ingiusto ed è questo che mi spinge a scrivere: sovvertire questa situazione. Sì, le cose finiscono, ma qualcosa continua».
Parliamo ora del suo ultimo libro, Il mio sottomarino giallo. La vita dei protagonisti è strettamente legata al mare e Lei ha già avuto modo di dichiarare che si tratta di un romanzo largamente autobiografico. In che modo, dunque, la sua vita è connessa a questo elemento?
«Sì, è una storia autobiografica, ma è anche un romanzo. Spesso quando scrivo prendo parti della mia vita e le mescolo alla narrazione, dunque diventano qualcosa di nuovo. Io vivo su un’isola, il mare è tutto attorno, non può non determinare ogni aspetto dell’esistenza. Sono stato sempre affascinato dal mare, dall’oceano, dalla sua potenza, quando resti lì a guardarlo sembra vivo. Scrivendo mi ci sento connesso».
Per scrivere dei suoi personaggi, delle creature che abitano il romanzo, ha fatto ricerche su miti e leggende islandesi o è tutto frutto della sua immaginazione?
«Per la maggiore sono completamente inventati, vengono dalla mia quotidianità, dalle mie esperienze. Quando do vita a un personaggio non penso mai alle sue caratteristiche prima di scrivere, è un qualcosa che prende forma sulla pagina, dalle interazioni con gli altri. Forse è appena diverso per il personaggio principale, ma il processo si delinea lungo la storia. Se vengono fuori da miti e leggende della mia terra? Non saprei, forse sono il risultato di entrambe le cose».
Ancor più che a Yellow Submarine, il romanzo mi ha fatto pensare a A day in a life. Perché i Beatles? E in che modo la loro musica racconta quella che è una storia di amicizia ma anche di passione per l’arte, la musica e la poesia?
«Potrei stare qui per ore a parlare del fatto che fossero dei musicisti incredibili, di quanto la loro musica fosse fantastica, di quanto cercassero di raggiungere il limite durante le loro studio-sessions, di come fossero sempre superiori a tutti gli altri; è impossibile – per quelli della mia generazione – non lasciarsi ispirare. Quando avevo dieci anni, andai in Norvegia dove viveva mio nonno, e lui mi regalò un disco dei Beatles, rimasi incantato da quella musica. Mi disse poi che non avrebbero suonato ancora insieme, che erano stati grandi amici ma che, in quel momento, si era rotto qualcosa. C’era questa foto sul retro di quell’album, erano insieme, ed era difficile non immaginarli più uniti. Le loro canzoni parlavano di amicizia, credo che fosse poi uno dei segreti della loro grandezza, l’essere grandi amici. Amici che stavano cambiando il mondo. Ricordo che avrei voluto volare a Londra e convincerli a tornare insieme. I ricordi di bambino mi riportano sempre a loro, quindi li sento legati a me per tanti motivi».
Le faccio ancora un paio di domande. Il romanzo è una metafora della vita stessa, tant’è che sulla scena appaiono tantissimi personaggi, molti dei quali secondari eppure fondamentali. Qual è il loro ruolo nella storia?
«Il bello con i personaggi secondari è proprio questo, in narrativa come nella vita, non sai quando appariranno sulla scena, quanto a lungo resteranno e magari con una sola azione possono indirizzare l’andamento delle nostre storie. A volte lo realizzi anche molto tempo più tardi che non funzionano e allora devi ucciderli, devi eliminarli dal racconto. Così esiti, ma capisci che devi lasciarli andare, che non fanno parte di quel mondo. E non è un fallimento, anche se doloroso, semplicemente non fanno parte di quella storia».
Qual era l’obiettivo principale nel creare un’opera come Il mio sottomarino giallo? Cosa spera che i lettori possano trarre da questa storia?
«Non penso mai all’impatto che le mie storie avranno sui lettori, ma al tempo stesso scrivo perché ce l’abbiano. È una contraddizione, ma sono grato di non lasciarmi influenzare. Se vuoi essere sincero e non perderti, è una parte fondamentale del processo. Il mio obiettivo era quello di capire la tristezza, di capire i rimpianti, di capire Dio. Spero che i lettori possano struggersi, che poi possano sorridere. Dal momento che finisco di scrivere, il libro diventa loro».