Mercoledì 31 agosto, la Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia stende il tappeto rosso e riaccende quelle luci ereditate dai dispositivi di proiezione che, in pieno fervore di fine Ottocento, i fratelli Lumière hanno magicamente inventato. È la settantanovesima edizione della Biennale di Venezia, e la settantanovesima occasione di incontro e dialogo per un’arte internazionale che, durante le serate che seguiranno, sfilerà nel vestito buono.
Sarà perché sono stati citati gli imprenditori francesi Lumière, sarà perché quest’anno il Leone d’Oro alla carriera verrà attribuito, su proposta del direttore della Mostra Alberto Barbera, a un’attrice francese (Catherine Deneuve), sarà perché si parla di luci che, innestandosi su uno schermo neutro, diventano il punto di riferimento per le ombre, che Jeanne Moreau entra in scena in questa riflessione e, anzi, ne diventa fulcro, attraverso la sua Luce del rigore.
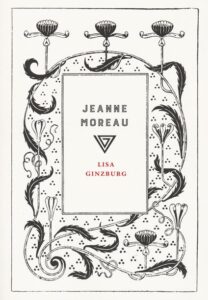 È la scrittrice Lisa Ginzburg (che con Cara pace, edito da Ponte alle Grazie 2020, entra nella dozzina del Premio Strega) a mostrare, con il sensibile trasporto di un’ammiratrice, la figura enigmatica e luminosa della diva francese Jeanne Moreau, così come le era apparsa in un cinema d’essai di Trastevere, la prima volta che l’aveva vista recitare. Lo fa, scrivendo di lei, nel primo volume della collana Mosche d’oro (diretta da Giulia Caminito, Viola Lo Moro e Nadia Terranova) pubblicato dalla Giulio Perrone Editore.
È la scrittrice Lisa Ginzburg (che con Cara pace, edito da Ponte alle Grazie 2020, entra nella dozzina del Premio Strega) a mostrare, con il sensibile trasporto di un’ammiratrice, la figura enigmatica e luminosa della diva francese Jeanne Moreau, così come le era apparsa in un cinema d’essai di Trastevere, la prima volta che l’aveva vista recitare. Lo fa, scrivendo di lei, nel primo volume della collana Mosche d’oro (diretta da Giulia Caminito, Viola Lo Moro e Nadia Terranova) pubblicato dalla Giulio Perrone Editore.
Avvolto in un lavoro grafico in bianco e nero, il testo introduce con capolettera, alla maniera miniata dei manoscritti artigianali, all’incontro con un’icona internazionale di bellezza e un’attrice raffinata e feconda che ha preso parte a centotrenta film e cinquanta pièce teatrali, ogni volta interpretati e abitati con lo stesso rigore di metodo, la stessa totale presenza. Jeanne Moreau è per Lisa Ginzburg un femminile possibile; è, fin dal primo sguardo sullo schermo, un modello di femminilità da seguire e inseguire, per comprendere e per comprendersi.
Quel “rigore naturale”, come lo chiama la stessa Jeanne, lo apprende da bambina da una zia, nella campagna sconfinata, dove non può sottrarsi all’assecondare la cadenza delle stagioni, allo sviluppare la pazienza, la cura e l’esercizio e al rispettare la noia che la natura, con i suoi tempi e i suoi silenzi, può significare per i suoi pochi anni. È il nonno materno, invece, che le spiega i movimenti delle maree, le fasi lunari e i codici delle costellazioni.
Figlia di una ballerina che ha rinunciato a una carriera alle Folies Bergère (il cui scorcio dallo specchio è brillante nel celebre dipinto di Edouard Manet) e un ristoratore dal carattere burbero che non accetterà l’inclinazione artistica della figlia, Jeanne è in un punto centrale, nel mezzo di due forze opposte, i suoi genitori; è tra il cielo stellato e il suolo campestre, tra sé e tutti gli altri. È questa la spiccata capacità a cui la scrittrice ritorna spesso e con ammirazione: alla centratura. Maestra di misura, Jeanne Moreau impara presto che l’equilibrio può essere la chiave per tenere a bada un’antica ferita.
È con pazienza che aspetta che la inondi la passione per il cinema, come si aspetta la pioggia, come se all’inizio sfuggisse anche a quella. Inafferrabile: nessuno è in grado di coglierla davvero […] Tutti – registi, direttori della fotografia, fotografi di scena – hanno raccontato quanto Jeanne Moreau sia stata difficile da fotografare. Mentre gli altri cercano di definirla, lei è già fuggita perché, consapevole della sua natura indomita – nella quale ripone un’assoluta fiducia – lascia agli altri la perfezione del suo lavoro e si sottrae a ogni definitiva rappresentazione.
Perfettamente centrata in un qui e ora al quale ha accesso lei soltanto, Jeanne sceglie secondo la sua etica, ascolta, sbaglia, comprende ciò di cui non ha bisogno e finisce nei luoghi giusti. Succede a Jeanne di conoscere Jean Renoir (che, tra l’altro, con il suo La règle du jeu è tra i “Classici fuori Mostra” della Biennale 2022), Ingrid Bergman, e un intero (sensazionale) mondo che le vortica intorno trovandola perfettamente all’altezza, in ogni circostanza.
Realizzare interiormente lo yin e lo yang, il sodalizio di poli discordi, il segreto della loro armonia, dà l’idea di una personalità esatta, inscalfibile, che nell’incontro con l’altro può anche trovare accoglienza, curiosità. Ha le migliori qualità che ci si aspettano da una donna, più quelle che ci si aspettano da un uomo, dice di lei il suo grande amico Truffaut. Lavorare insieme al film Jules e Jim ha rappresentato per entrambi uno stato di grazia, tanto che Jeanne commenterà a riguardo: C’era la nostra giovinezza, non adolescente ma adulta, cioè leggera e profonda insieme.
Gli amici e gli amori li costruisce in relazione al lavoro, perché resta questo il punto focale che richiama e assorbe ogni cosa, il significato su cui poggia il costante funambolismo dell’esistenza. Le amicizie maschili sono uno spazio in cui respirare ed esprimersi liberamente, in cui mescolare il proprio lato maschile e quello femminile, farli dialogare con i rispettivi lati nell’altro. Complice anche con le donne – un po’ meno con Brigitte Bardot – Jeanne si lega, tra le altre, alle scrittrici Marguerite Duras e Henriette Jelinek in una generosa sintonia.
Nei legami d’amore, però, mantiene la misura più rigorosa, facendo fede a quel patto di completezza rivelata a sé con un unico strappo. La vita sentimentale la chiama, a tratti la occupa e la conquista, senza che però mai Jeanne voglia trarne teorie. Quella del desiderio è dimensione naturale, che si intreccia col suo stare al mondo: una scossa alla cui forza sovvertitrice Jeanne tuttavia mai permette di prendere il sopravvento.
Più che con l’altro, la distanza la Moreau la prende dal sentimento, quella fiamma che può diventare un temibile impegno, quel morso da assaporare intensamente e poi ritirarsi con lucidità, senza alcun rimpianto, perché non è disposta a rinunciare all’autosufficienza emotiva che, come un involucro, le fa da scudo e rifugio. «Era sempre alla ricerca dell’amore, dopodiché lasciava le sue vittime sul bordo della strada» pare siano state le parole di Marcello Mastroianni.
La Jeanne croqueuse d’hommes (mangiauomini) di cui si parla sui giornali è la stessa che si legherà profondamente al suo grande amore, il giovane regista dall’aria geniale Louis Malle, che da lei resta letteralmente folgorato in occasione di un pranzo piovoso. È la stessa che, per via di un rifiuto di Coco Chanel, viene indirizzata presso quel nuovo stilista, Pierre Cardin, che, determinata, conquisterà all’istante, coinvolgendolo in un rapporto libero che prescinde dalla sua omosessualità.
Lisa Ginzburg lascia poi parlare le fotografie quando ritraggono l’attrice insieme al primo e al secondo marito (Jean-Louis Richard e William Friedkin); sono entrambi periodi della sua vita così poco felici che, davanti all’obiettivo, lei non riuscirà a dissimulare e che faranno crollare del tutto quell’idea di stabilità che tanto già vacillava.
Convinta da Cardin, Jeanne acquista una dimora a Prèverger, concependola come la casa dell’infanzia che non ha mai avuto. Una volta ha risposto così a un intervistatore: “Casa” cosa mi evoca? Facile: casa è il nido, il rifugio, luogo di riunioni di amici, è un focolare, una fonte di calore umano dove ci è dato ridere, piangere o amare.
Ma le radici sacre le trova nella solitudine, un posto necessario quanto necessarie sono le relazioni. Il silenzio è per lei religioso quanto il lavoro, quanto il mettersi al servizio dei ruoli dell’arte ora con autorità ora con arrendevolezza. Appartarsi con la propria natura selvaggia è vitale per rimarcare il confine che le rende le altre persone care sì, ma sempre meno indispensabili. Per Jeanne Moreau la mancanza non pesa, ma solleva, o almeno è da ricercare per soppesare il tiro e riequilibrare il suo universo.
Jeanne – che fece scandalo al Festival di Venezia (con il film Gli amanti di Louis Malle, film che però si aggiudicò il Leone d’Argento nel 1958) e che vinse alla Mostra del 1992 il Leone d’Oro alla carriera – magnetica, vitale, sincera, enormemente presa da sé, eppure attentissima agli altri, sfacciatamente equilibrata, emerge quindi come un simbolo di femminilità autentica e slegata che, pur non ricevendo un’immagine mediatica sempre favorevole, è il riflesso di una donna che ha vissuto camaleonticamente, conoscendosi e riconoscendosi, al ritmo dell’appartenenza e della non appartenenza, purché niente di sé vada sprecato nell’inespressione.








