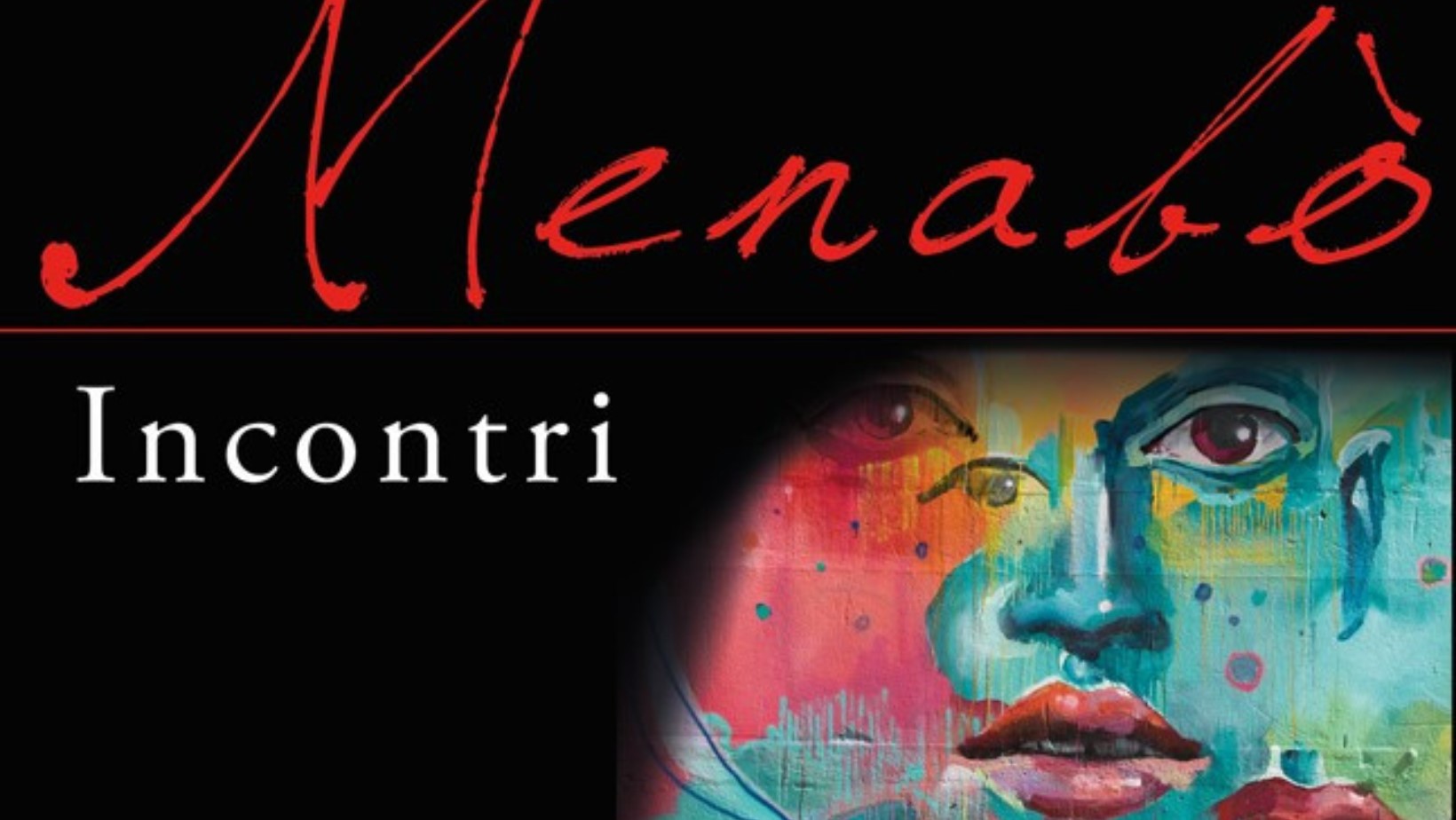Nei musei mi perdo sempre, e anche stavolta non ho fatto eccezione. Le Gallerie d’Italia – da poco aperte in via Toledo, a Napoli – mi sembrano uno spazio infinito, fatto di piani che confluiscono in altri piani e scale che conducono in dimensioni parallele. Una guida mi osserva vagare senza scopo e dopo qualche secondo mi dice: «Per Artemisia di là». Dopo altre scale e altre porticine, mi ritrovo finalmente in una sala enorme.
Dei grossi pannelli neri sono disposti in tutto lo spazio e sorreggono imponenti quadri di dee, ninfe, sante e madonne in vesti scarlatte. Sembra un labirinto di donne giganti che osservano altezzose i passanti. Ad attrarmi però sono le tele più piccole, sparse sui pannelli scuri come finestrelle accese nella notte. La sala è gremita, Artemisia – dopo il Caravaggio al primo piano – è il pezzo forte del museo. Dopotutto, anch’io sono qui per lei.
Quella organizzata da Gallerie d’Italia – Artemisia Gentileschi a Napoli – è un’esposizione monografica ampia e ricercata e racconta il lungo soggiorno napoletano della pittrice documentato tra il 1630 e il 1654. La bottega di Artemisia ebbe un successo enorme sul territorio partenopeo, ai tempi animato da un fervore artistico incredibile. Le opere provengono da raccolte pubbliche e private, italiane e nazionali, e rimarranno al museo fino al 19 marzo del 2023.
La prima sezione della mostra è dedicata alle eroine classiche e giudaico-cristiane, ma in mezzo ci scopro anche degli autoritratti. Artemisia si raffigura come Clio, musa della Storia, o come Santa Caterina d’Alessandria, con l’aureola e lo sguardo fiero, e infine come allegoria della pittura, rapita dalla sua stessa opera. È perfettamente a suo agio nei panni di queste figure leggendarie: dopotutto, un’eroina lo è diventata anche lei nel nostro immaginario.
Non può che affascinare quella bambina che, innamoratasi dei pennelli e dei colori di suo padre Orazio, dimostrò un talento innato per la pittura. Una bambina che, diventata ragazza, coltivò – celata tra le mura di casa sua – una passione proibita alle donne. Artemisia Gentileschi, la pittrice che, nonostante il divieto di dedicarsi all’arte imposto al genere femminile, riuscì ad aprire la sua bottega e ad affermarsi.
Avanzo tra i pannelli espositivi e mi fermo di fronte al dipinto di una donna che stringe un vassoio in mano. Su di esso, è posata la testa mozzata di un uomo. La donna che la esibisce fieramente si chiama Giuditta, l’eroina biblica che, per salvare la sua città, entrò nel campo militare nemico come finta traditrice. Il generale Oloferne se ne invaghì, tentò di possederla, ma venne decapitato dalla donna e dalla sua ancella.
A pochi passi scovo un dipinto di Dalila, con le forbici in mano, che taglia la chioma di Sansone per privarlo della sua forza. La sua figura è meno onorevole, agisce solo per il denaro che le hanno promesso i Filistei, ma stringe la mano della sua ancella proprio come Giuditta. Sono vendicative e ferali le eroine della Gentileschi, esprimono forse una rabbia covata dalla loro creatrice, costretta per anni a nascondersi in casa per dipingere in un mondo riservato agli uomini.
I pannelli cominciano a virare sul rosso: entro, dopo poco, nella sezione dedicata a Eros e Thanatos. I corpi di donne nude o seminude sono in bilico tra morte ed erotismo, sensualità e violenza: spicca tra tutte Cleopatra, avvolta solo di una stola blu, cianotica e riversa sul letto, appena morsa dal serpente. Era raro, tra i contemporanei di Artemisia, ritrarre l’ultima delle regine d’Egitto nei suoi attimi di vita finali.
Tra le opere di questa sezione, c’è Susanna e i vecchioni. Secondo il racconto biblico, due uomini si introdussero nel giardino della bella Susanna: la scovarono nuda mentre si faceva un bagno. I due, colti dalla lussuria, minacciarono di accusarla di averla sorpresa con un giovane amante se non si fosse concessa a loro. E così accade: Susanna viene portata di fronte a un tribunale, riconosciuta colpevole e condannata a morte.
È un uomo, il profeta Daniele, a salvare Susanna dalla lapidazione. Senza di lui, i vecchi sarebbero riusciti a manipolare l’opinione pubblica – la voce di una donna non era considerata credibile in tribunale come quella di un uomo – e Susanna sarebbe morta, colpevole solo di essersi sottratta alle loro mani.
Osservo il quadro di Susanna, nuda e orripilata dagli sguardi lascivi dei vecchi, e non posso fare a meno di pensare a ciò subì la stessa Artemisia. La pittrice a diciotto anni fu violentata da Agostino Tassi e dopo un anno intentò contro di lui – per mezzo di suo padre Orazio – un processo per stupro, tra le più importanti causes célèbres del Seicento.
Non era scontato, ai tempi, denunciare uno stupro. Secondo Elizabeth Cohen, il reato di violenza sessuale nella prima età moderna in Italia non era percepito come aggressione alla donna. Anzi: nel momento stesso in cui il fatto si veniva a sapere, l’onta della violenza ricadeva sulla vittima. Tra la gente sarebbe serpeggiata la parola puttana e la donna avrebbe perso il suo onore: ormai era impura e nessun uomo l’avrebbe più voluta.
Così fu per Artemisia che, denunciando, divenne – proprio come Susanna – una prostituta agli occhi del pubblico. E la migliore difesa che il suo stupratore poteva mettere in campo era assecondare quelle voci. Agostino Tassi corruppe una serie di testimoni che in tribunale dichiararono che Artemisia era una libertina, una poco di buono, e che lei e suo padre stavano cercando di incastrare l’imputato in un matrimonio.
A sostenere questa tesi, c’era il fatto che padre e figlia avessero denunciato solo dopo un anno dal supposto stupro. Orazio Gentileschi provò, infatti, a tentare un matrimonio riparatore con Tassi per salvare sua figlia Artemisia dall’onta di un processo pubblico. Tentativo che fallì poiché l’uomo era segretamente già sposato.
Una domanda risuonava nella città: perché ci hanno messo tanto? La stessa domanda con cui, anche oggi, è stata messa indubbio l’ondata di denunce e testimonianze in seguito alla diffusione del movimento #MeToo. In Italia, basti ricordare la polemica relativa a Ciro Grillo e il dibattito allucinante che ne scaturì. La risposta a questi ritardi, in realtà, è semplice: oggi, come allora, denunciare non assicura alcun risultato.
Può, al contrario, ritorcersi contro la vittima, dato che meno di un processo di stupro su tre giunge a condanna e in tutti la vittimizzazione secondaria è messa in atto. Quest’ultima è la tendenza di ribaltare la situazione e mettere la vittima al banco dell’imputato. Dal non dovevi ubriacarti al perché ci sei andata, fino allo sguardo inquisitore sui vestiti o la condotta della vittima: chi denuncia subisce un processo alla sua moralità.
1979: Processo per stupro, il primo documentario su un caso di violenza carnale, viene trasmesso nelle televisioni italiane. La vittima, una ragazza di diciotto anni, era stata violentata da quattro uomini: durante il processo la difesa si trasformò in accusa, mettendo in risalto i comportamenti libertini della ragazza. L’avvocato della diciottenne si trovò a dover ricordare che il suo ruolo non era quello di parte difensiva, ma di legale dell’accusa che imputava ai quattro uomini una violenza carnale.
1610: Tuzia, inquilina dei Gentileschi, testimonia contro Artemisia descrivendola come una libertina e le contrappone il comportamento dignitoso del suo stupratore. La giovane pittrice venne sottoposta a un’umiliante visita ginecologica: due ostetriche stabilirono che non era più vergine da tempo. La prova venne usata in corte dall’accusa per ribadire la promiscuità sessuale della pittrice.
Dopo la prova della non verginità di Artemisia, le sue testimonianze persero di credibilità. Per questo, la donna fu sottoposta alla tortura della Sibilla: le vennero legate delle cordicelle attorno alle dita e tirate finché non avesse ammesso che l’accusa di stupro era in realtà una calunnia. Artemisia, rischiando di perdere le dita e la possibilità di dipingere, non cedette mai al dolore e non ritrattò la sua versione.
2008: una giovane ventiduenne denuncia uno stupro di gruppo di cui è stata vittima durante una festa a Firenze. Nel 2015 la Corte d’Appello assolve i sei imputati. Nel 2021, la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo stabilisce che la sentenza del 2015 è basata su stereotipi sessisti: alla vittima sono state fatte domande sulla biancheria intima indossata, sulla sua vita privata e il suo orientamento sessuale e in base a queste indagini è stato stabilito che il fatto non sussiste.
Passano i secoli, ma la cultura dello stupro è ancora radicata. Si tratta di un complesso di credenze che incoraggia l’aggressività sessuale maschile e supporta la violenza contro le donne, spesso incolpandole dei fatti accaduti. Abbiamo più tutele giuridiche rispetto ai tempi di Artemisia, eppure i giudizi e le calunnie sopportati dalla pittrice sono ancora all’ordine del giorno in ogni singolo dibattito attorno a un caso di violenza.
Il processo intentato dai Gentileschi si concluse con la condanna e l’esilio di Agostino Tassi. Orazio riuscì a provare la corruzione dei testimoni da parte dell’accusato e a ribaltare l’andamento del processo. Le testimonianze – sempre lucide e coerenti – di Artemisia fecero la loro parte ma, come nel racconto biblico di Susanna, se non ci fossero stati dei testimoni maschi (amici di suo padre) a sostenerla non sarebbe stata mai creduta.
Mi avvio verso l’ultima parte della mostra, che si chiude con quattro tele: due dipinti di Artemisia – la Corisca e il satiro e il celebre Trionfo di Galatea – accompagnati da Orfeo dilaniato dalle baccanti di Massimo Stanzione e il Ratto d’Europa di Anna Di Rosa. Si tratta di quattro favole mitologiche: il tentato stupro della ninfa Corisca, il rapimento di Europa da parte di Zeus e l’uccisione di Orfeo da parte delle baccanti.
I ruoli sessuali e la violenza di genere sono protagonisti, ma il dipinto che più mi colpisce è il Trionfo di Galatea di Artemisia. Nel mito, il ciclope Polifemo, invaghitosi di Galatea, tenta prima di possederla e poi, dopo aver fallito, uccide l’uomo che lei ama. Galatea però è una nereide, una ninfa del mare, e dopo aver tramutato il suo amato in fin di vita in un fiume riesce a scappare su una conchiglia trainata da delfini di fronte all’impotente Polifemo.
Galatea è bella nella sua vittoria, bianca e divina. E lo è anche Artemisia, che riuscì a riscattare sé stessa dopo il processo: la pittrice fu la prima donna a entrare a far parte dell’Accademia del Disegno e diventò talmente famosa da attrarre pittori e viaggiatori da tutto il mondo. A testimoniare il trionfo di Artemisia sono proprio le tele racchiuse tra le mura delle Gallerie d’Italia, che le hanno fatto guadagnare un posto nella storia.