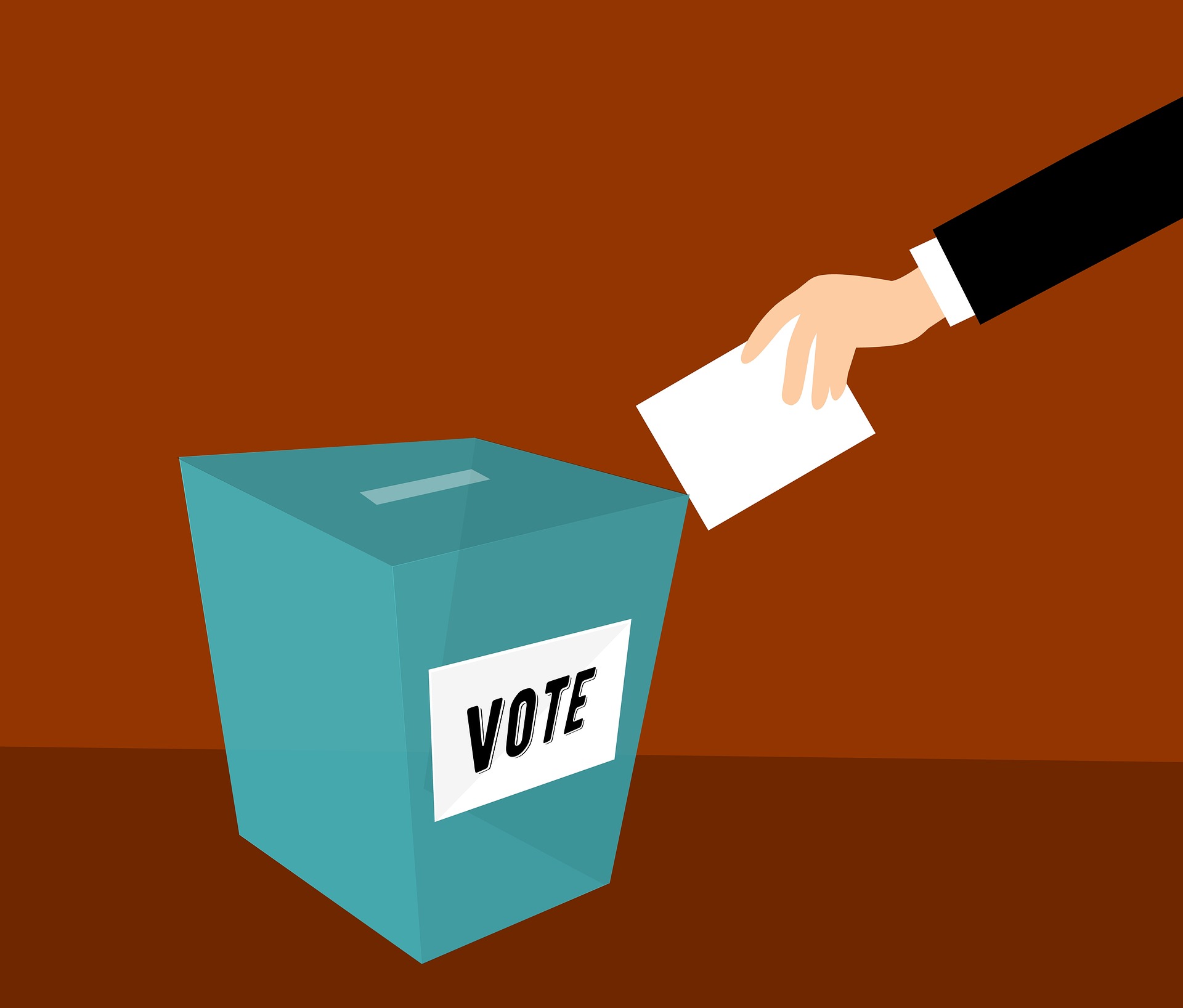Per anni, e con una frequenza sempre maggiore, Mar dei Sargassi ha scritto di femminicidio e violenza di genere. Per anni, abbiamo cercato parole che potessero, in qualche modo, raccontare una società che stava cambiando e che, probabilmente per questo, andava scricchiolando ridefinendo ruoli e gerarchie. Abbiamo raccontato storie, nomi, aggressioni, paure che accomunano tutte in quanto donne, pensando – e facendolo ancora – che fosse necessario, doveroso, imprescindibile parlare, farsi sentire, impegnarsi prima come cittadini e, poi, come operatori dell’informazione.
Da giorni, tuttavia, ci interroghiamo sulla storia di Giulia Cecchettin, su quella che era una scomparsa, poi diventata rapimento, e sulla brutalità del suo assassinio. Ci interroghiamo, mentre il sorriso dolce di una ragazza che fino a poco più di una settimana fa non conoscevamo sembra attraversarci, oltrepassare gli schermi, chiederci conto. Ci interroghiamo e fatichiamo a trovare un modo che ci sembri giusto, efficace, pieno di contenuto e vuoto di retorica. È difficile.
È difficile perché la nostra, in gran parte, è una redazione di donne e giovani donne. Di sorrisi che hanno guardato nell’obiettivo con la stessa naturalezza, la stessa vitalità, la stessa determinazione di Giulia. Di relazioni che avrebbero potuto o, ancora, potrebbero somigliare a quella tra Cecchettin e Turetta per scoprirlo dopo, quando è tardi.
Non serve andare troppo a fondo per riconoscere che le storie di femminicidio si somigliano tutte. Si somigliano perché, spesso, nascono dalla volontà dell’abusata di lasciare l’abusante che, a sua volta, non può tollerare l’affronto. È questione di proprietà e di onore, di vita e di morte. Di morte, soprattutto. Ma non soltanto: l’antropologa messicana Marcela Lagarde, la teorica del femminicidio, specifica infatti che la parola non definisce solo l’uccisione, l’atto finale, ma anche tutte quelle forme di discriminazione e di violenza che lo sostengono e lo precedono. E quante se ne possono raccontare?
Potremmo dire che sono i segnali, quelli che ogni volta che un uomo ammazza una donna si ripete che lei avrebbe dovuto riconoscere muovendole come un’accusa. Non sempre, però, la violenza si esercita con l’utilizzo della forza fisica. Non sempre è uno schiaffo o un’offesa, seppur pesante, a lanciare quei famosi segnali. A volte è niente, a volte è un attimo, a volte è così intrinseco l’abuso da apparire naturale, impercettibile. E anche noi, che siamo qui a scriverne, potremmo non accorgercene.
Non sempre ci sono gli estremi per una denuncia. E quando ci sono, spesso, sembrano non bastare. I casi di donne che hanno denunciato a vuoto i loro futuri assassini sono tantissimi. Talmente tanti che, di frequente, finiscono con l’inibire chi subisce violenza a rivolgersi alle autorità per non sentirsi ancora più sola e impotente, destinata a una morte che sembra inevitabile, la punizione per aver amato la persona sbagliata. Ma amare non è uno sbaglio.
È difficile, allora, perché la nostra, in gran parte, è una redazione di donne che hanno amato. E hanno amato i bravi ragazzi. Perché sì, si può essere bravi ragazzi e assassini. E non è un corto circuito, è la natura spesso ambigua, ambivalente, polimorfa degli esseri umani. Lo ha ben sintetizzato la sorella di Giulia, Elena, che ha invitato tutti a rivedere il concetto di “mostro” in riferimento a Filippo, l’omicida, perché «un mostro è un’eccezione, una persona esterna alla società, una persona della quale la società non deve prendersi la responsabilità. E invece la responsabilità c’è». Può suonare retorico ma è il primo passo necessario per una collettività che non sia più basata sull’uso della forza come mezzo di prevaricazione. Lo dice anche Nicola Lagioia: «Bisognerebbe sapere molto del carnefice per capire che la distanza che ci separa da lui è minore di quanto crediamo».
È difficile. È difficile perché la nostra è una redazione composta anche da uomini e in un momento come questo, in cui il dibattito è totalmente polarizzato, si rischia di farsi torto reciproco. E, invece, è insieme che vogliamo muoverci, che ci stiamo interrogando, confrontando, che tentiamo di capire quale possa essere la strada. Perché abbiamo capito che è questa la sola possibilità: parlarne, mettere in ordine i pensieri e gli istinti. Cercando le parole, scandagliando il fondo di un dizionario che non sembra mai giusto affinché non suoni come un contentino alla nostra rabbia, alle nostre paure, all’algoritmo che fagocita ogni riflessione, banalizzandola.
Mentre i social si riempiono di post e storie tutti uguali, di invettive in serie e proposte degli influencer – scrive Jonathan Bazzi –, noi ci sentiamo a disagio. Per i toni, per le modalità, per la risposta forse persino controproducente. Risposta veicolata dai creator di Instagram […], i cui termini – semplicistici, unilaterali, autopromozionali – vengono ripresi poi anche da editorialisti e politici. Perché «c’è un’emergenza in corso», «le donne vanno protette», certo, ma sui social soprattutto oggi vogliamo piacere, dunque ci si accoda ai trend, a ciò che si vede funzionare.
La reazione instillata è banalizzante, non specialistica, e piegata alle logiche del personal branding. Più semplifico e polarizzo, e più sarò visto. Che sia utile, tolta la fiammata di indignazione del momento, non è ciò che conta. Per noi, invece, è importante. Per noi conta. Per questo ci interroghiamo. Per questo cerchiamo le parole e lo facciamo guardandoci negli occhi. Perché non siamo indignati. Siamo preoccupati. Siamo arrabbiati. Ma siamo pure stanchi di tutto questo inutile parlare.
Dal pulpito della politica, che pensa a inasprire le pene e a introdurre normative più restringenti, ma si astiene o, addirittura, vota contro la richiesta di adesione dell’Eurocamera alla Convenzione di Istanbul; che depotenzia i CAV e le case rifugio. Una politica, espressione di Stato, incapace di ascoltare e proteggere, di garantire la giusta tutela a ogni sua componente, a chi a essa si affida – o dovrebbe affidarsi – per evitare di finire in prima pagina, immortalato per sempre in un sorriso inconsapevole di essere l’ultimo.
La stessa che, inseguendo il trend, individua la panacea di tutti i mali nell’educazione affettiva, sentimentale o di genere che dir si voglia, riducendola a un paio d’ore settimanali a scuola, nell’orario extracurricolare, demandando ad altri una responsabilità che è di tutti. Anche di quelli oggi in Parlamento ma fino a qualche anno fa a sventolare bambole gonfiabili sui palchi della propaganda. Sono gli alleati di una donna, la prima al governo, che non conosce battaglia in nome di diritti, di femminismo, di violenza di genere, di uguaglianza: perché – lo abbiamo scritto in tempi non sospetti – non basta certo Giorgia Meloni, rappresentante della destra più antica, retrograda e, anzi, conservatrice di vecchi dogmi, al sesso femminile. Il che ci riporta al cuore del problema: non è il chi, ma è il cosa il nemico. Il machismo, il patriarcato, il capitalismo.
Sono stati giorni di attesa, quelli appena trascorsi, giorni in cui sapevamo, tutti, che Giulia non sarebbe tornata, che di lei avremmo parlato al passato come, ormai, si fa di ogni donna che diventa cronaca. Di ogni nome che, di colpo, diventa amico. E Giulia, come le altre, da sconosciuta si è scoperta sorella. Sorella di tutte. Ma anche di tutti. Centocinque, anzi centosei mentre scriviamo, donne di ogni età uccise nel solo 2023 perché… donne. Un dato costantemente in crescita, di anno in anno, a dimostrare che gran parte del dibattito di queste ore è basato sul nulla, su una logica emergenziale che svia la natura della questione che è atavica, antica come il mito o la tragedia, i primi racconti di stupro.
Non si può pensare che gli assassini di domani smettano di esserlo con l’autocoscienza, scrive ancora Bazzi. Le letture semplicistiche e galvanizzanti dei social danno la convinzione di occuparci dei problemi, ma non è così. […] Questo ci porta a non avere più molto interesse per la complessità, che fa rima con realtà, e ha a che vedere anche con lo studio, la sospensione del giudizio, le proposte magari meno capaci di aggregare consenso ma più necessarie.
Complessità che richiede spesso di sacrificare qualcosa, e non di guadagnare – collaborazioni e sponsor, commissioni e contratti – come accade oggi, a chi sfrutta questi temi per ingraziarsi gli algoritmi.
Per questo è difficile. Perché noi non sappiamo farlo, inseguire la notizia per ingrassare la community dimenticando la comunità. Siamo, dunque, cattivi giornalisti? Forse. Siamo in cerca di risposte? Sicuramente. Soprattutto siamo pieni di domande. Ci mettiamo in discussione, ci interroghiamo, vogliamo fare. Vogliamo e dobbiamo bruciare: di passione, di idee, di cambiamento e rivoluzione. Perché, diceva Bolaño, abbiamo l’obbligo morale di essere responsabili delle nostre azioni e anche delle nostre parole e perfino dei nostri silenzi.