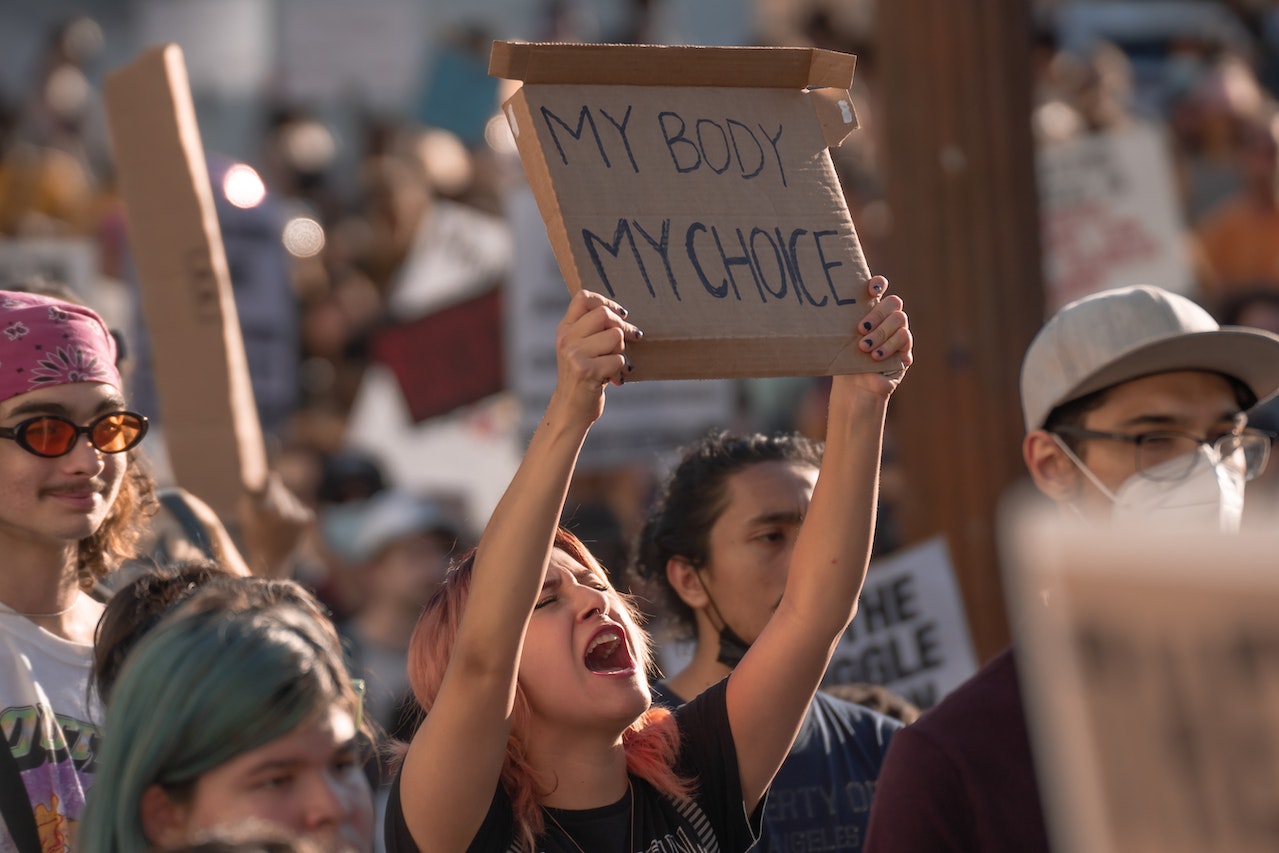Scrivere di Dahmer è difficile, com’è difficile, in generale, scrivere di true crime senza lasciarsi andare ai sensazionalismi e alle scabrosità. In questo caso, però, la serie Netflix incrocia, nel mondo rappresentato on-screen e off-screen, più di una tematica che vale la pena riprendere e comprendere nel discorso sulla fascinazione verso la cronaca nera, di cui in passato abbiamo già affrontato alcuni aspetti.
La serie tv prende il nome del serial killer Jeffrey Dahmer, attivo tra il 1978 e il 1991 a Milwaukee, negli Stati Uniti, artefice dell’uccisione violenta di diciassette giovani e giovanissimi uomini. A interpretarlo, un Evan Peters sconvolto dall’esperienza che appare sulla locandina ufficiale di Netflix con delle lenti a contatto da cosplay gialle come quelle di un demonio.
Al di sotto delle lettere che campeggiano, ciascuna lapidaria e solenne, sillabando il nome del killer all’inizio di ogni episodio, compare ogni volta un sottotitolo, più simile a una postilla: Monster. Quella che lo spettatore si accinge a guardare comodamente dal divano è la storia vera di un vero mostro: un essere diabolico, disumano, venuto fuori dalla bocca dell’inferno o da un film dell’orrore. Manco a farlo a posta, il regista della serie è Ryan Murphy, showrunner di American Horror Story. La nota saga televisiva (oltre a vantare Peters nel cast fisso) ha inserito più volte, tra le fila dei suoi personaggi da incubo, anche i serial killer e, tra questi, proprio Jeffrey Dahmer.
L’accostamento di orrore reale e orrore di fiction serve il duplice scopo di ribadire il dominio di finzione entro il quale si svolge la narrazione della serie tv, nonostante questo venga ripetutamente smentito dalle pretese di adesione alla realtà quasi al punto da riprendere, fotogramma per fotogramma, interi spezzoni della vicenda, così come venne mandata in onda per la prima volta negli anni Novanta dai telegiornali locali e nazionali americani che seguirono il caso e il processo, e prendere le distanze da Jeffrey Dahmer e dalle sue azioni.
Questo prendere le distanze è preliminare e indispensabile al racconto di cronaca nera perché, raccontare le efferatezze del killer seriale con dovizia di particolari, è come rimetterle in scena, come venire allo scoperto affermando che più del dolore, più della sofferenza delle vittime, ci interessa lo spettacolo.
Uno degli aspetti eticamente più controversi del racconto di true crime è, in effetti, proprio questo: nel reiterare il racconto del crimine, le vittime muoiono ancora e ancora, negando ai loro nomi e alle loro facce la serenità del ricordo vivo e integro, barattandoli con il numero della vittima e la quantità di colpi sferrati dall’assassino.
La serie su Jeffrey Dahmer non fa eccezione. A dispetto di un apparente trattamento rispettoso delle persone uccise (raramente Murphy indugia in scene di violenza esplicita o morbosità, preferendovi una suspense carica di nefando significato), alcuni parenti delle vittime del killer di Milwaukee sono insorti dopo la messa in onda della serie per non essere stati neppure consultati dalla produzione ed essersi ritrovati dinanzi al fatto compiuto di un programma televisivo in streaming in buona parte del mondo che esibisce il loro dolore, riproducendolo fedelmente dai documenti audiovisivi dell’epoca. A questo si aggiunga la massiccia quantità di persone che, online, hanno espresso il proprio disappunto per la mancanza di scene più vivide o la propria empatia con l’assassino, dichiarandosi suoi fan.
Questo aspetto è ben evidenziato in alcuni passaggi della serie Netflix, quando un Dahmer ormai all’ergastolo comincia a ricevere lettere da ammiratori che lo innalzano a simbolo di ribellione e sfida (qualcuno stampa addirittura un fumetto del killer che fa a pugni con Gesù Cristo), quando la sua vicina traumatizzata Glenda Cleveland si apre al lavoro con una collega per ricevere di risposta una ramanzina sullo stadio confusionario di lei durante l’orario d’ufficio e la richiesta di dettagli sulle condizioni in cui versavano le vittime uccise nell’appartamento accanto. L’identificazione dell’assassino con il mostro, proprio perché lo allontana da noi, lo rende più simile a un personaggio di una fiaba nera, in qualche modo ce lo avvicina sul piano ideale, i suoi crimini non sono più verità di dolore ma metafore fumose di un malessere impresso nella carne evanescente di vittime fantoccio.
Gli uomini sequestrati e uccisi da Jeffrey Dahmer appartenevano tutti o quasi tutti a minoranze etniche e alla comunità afroamericana LGBTQ+. Qui viene fuori un altro punto cruciale della serie, un altro ponte fra il mondo rappresentato e quello reale. Di fatto, il killer poté agire pressoché indisturbato per diversi anni perché la scomparsa delle persone nere e gay veniva trattata dalle forze dell’ordine di Milwaukee con sufficienza, diffidenza, razzismo e una punta di imbarazzo omofobico.
Alle ripetute segnalazioni che la signora Cleveland inoltrò alla polizia di rumori sospetti, colluttazioni e cattivo odore provenienti dall’appartamento di Jeffrey Dahmer, seguirono solo commenti scocciati del centralino del 911. Siamo oltre la sottovalutazione delle circostanze, sembra volerci dire Ryan Murphy a ogni sequenza della serie: Dahmer godeva del privilegio bianco, che lo rendeva al di sopra di ogni ragionevole dubbio. Le sue vittime, invece, erano già vittime di pregiudizio razziale, dimenticate silenziosamente ai margini da una società più simile al proprio carnefice che non a loro.
Ecco che il volto mostruoso di Dahmer si trasfigura, allora, nel volto mostruoso di una società le cui fondamenta poggiano sul razzismo sistemico e sullo sfruttamento e la cannibalizzazione del corpo non-bianco. Il serial killer, il mostro, è il grumo nero e denso delle mostruosità che, sparse, abitano già la società.
Nei lunghi flashback che occupano le prime puntate della serie Netflix, la telecamera si sofferma spesso sui corpi di piccoli animali vivisezionati nei laboratori di biologia delle scuole americane: la vita che si spegne al servizio di un capriccio superiore e annoiato. Nei momenti successivi all’arresto, è come se la società stessa venisse chiamata allo scoperto insieme all’assassino e il razzismo attentamente celato dall’opinione pubblica si riversa sulle famiglie delle vittime, cui viene intimato il silenzio e il classico adagio tornatevene al vostro paese. La morale della società, incarnata simbolicamente nella figura del padre di Dahmer, sempre pronto al senso di colpa e mai a farsi carico delle proprie responsabilità, è piagata dall’avarizia e dalla corruzione e, intravista la possibilità di lucrare sulla storia del figlio killer, ci prova senza remore o freni.
Ironia della sorte, o forse prova di quanto sia radicato il male che affligge la società americana, allo stesso destino ha ceduto la serie che, mentre denuncia la spettacolarizzazione del crimine sulla pelle razzializzata delle vittime, fa lo stesso rinunciando a mettere al corrente le famiglie degli scomparsi e tagliando fuori dalla produzione le persone nere (una delle assistenti alla produzione ha denunciato di essere stata trattata malissimo sul set e di venire costantemente confusa con l’unica altra persona nera nella stanza).
Si diceva, il true crime tende sempre a essere eticamente controverso. Allo stesso tempo, però, la serializzazione (un gioco di parole voluto) e il racconto romanzato di storie come quella di Dahmer offrono un modo per scrutare nell’abisso. Più ancora che la mente dell’assassino, cui, pure, è stato ispirato un romanzo, Zombie di Joyce Carol Oates, è interessante e importante esplorare la crepa buia che permette, nelle nostre società, la formazione di disparità e disperazioni tali da generare mostri.
Nel caso italiano e assolutamente diverso (se non in parte per l’esito sanguinoso) della serial killer Milena Quaglini, ad esempio, raccontato da Elisa Giobbi in Milena Q. – Assassina di uomini violenti (Mar dei Sargassi Edizioni), il delitto consumato, seppur mai giustificato, è conseguenza evidente delle negligenze del nostro sistema sociale. Quaglini, prima ancora di diventare carnefice, è vittima posta ai margini di un mondo che ne sottomette e ne abusa il corpo in quanto donna. L’esplorazione romanzata della violenza operata dal true crime, dunque, può costituire un luogo d’indagine del male che ci riguarda tutti, a patto di non romanticizzarlo.