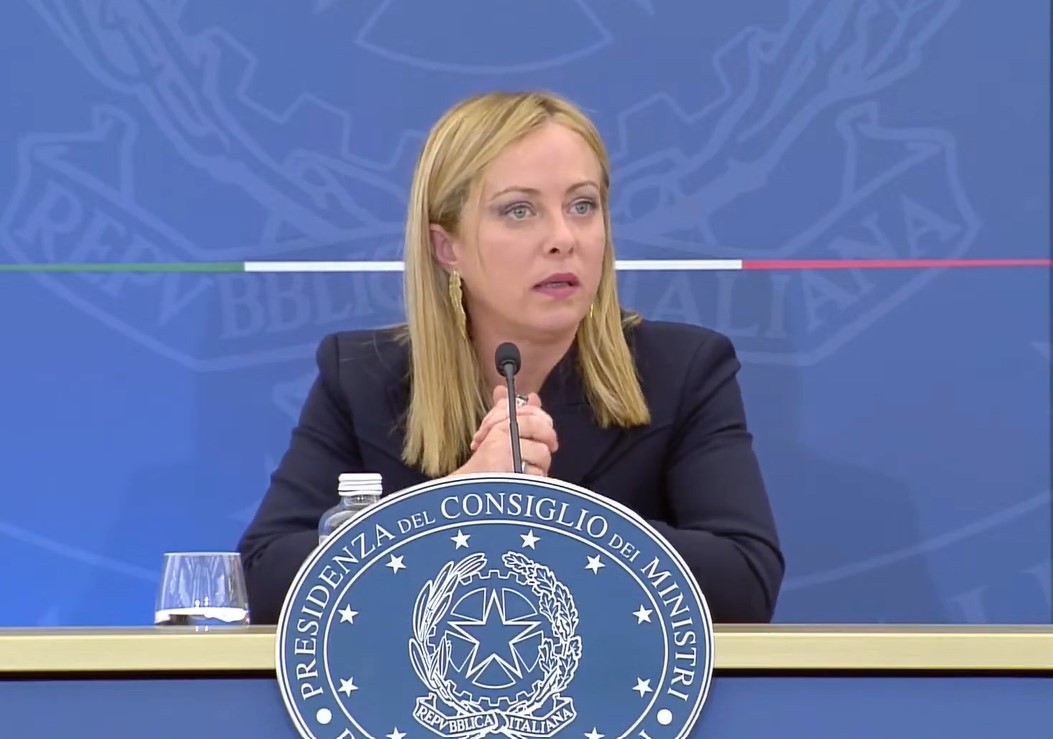L’intervista a Giulia Muscatelli, autrice di Balena (nottetempo), avviene al crocevia della stazione. Il ronzio gracchiante prodotto dal vivavoce è una presenza ingombrante fra me e le parole di lei, così come sono ingombranti il rotolio ossessivo dei trolley, il vociare dei passanti, il volume troppo alto della musica di bar che si fissano ostili da un capo all’altro della Food Hall e si fanno concorrenza a colpi di decibel. La storia di Balena, però, si fa strada attraverso il telefono e riempie l’aria.
Balena è il memoir inaffidabile – perché inaffidabili sono i ricordi, dice Muscatelli – dell’adolescenza della scrittrice, vissuta tra il lutto per la morte improvvisa del padre amatissimo, l’esigenza di appartenersi oltre la fine, il desiderio di occupare spazio e la vergogna di un pudore imposto.
Giulia Muscatelli mi ha parlato di corpi. Quello assente di qualcuno che si ama e si è perduto, quello che resta e che cerca di colmare la mancanza colmandosi. E ho trovato particolarmente significativo che la nostra conversazione si sia svolta in una condizione di evanescenza, un incontro fra due voci senza corpo unite dal filo invisibile della rete telefonica, nel luogo in cui, per eccellenza, si è corpo sospeso, indefinito, fra un intervallo di partenza e uno di arrivo.
L’impulso a farsi storia, a raccontarsi è, invece, definire l’intervallo del vissuto, spostare il peso gravitazionale verso il proprio centro, modellarsi un corpo nuovo da abitare. Balena c’è già passata, lo ha costruito quel corpo: prima, provando a espanderne i confini, rivendicando al suo interno uno spazio comodo per sé e per i suoi affetti; poi, celandolo, travestendolo, vergognandosene. Infine, facendogli indossare l’abito trasparente e scollato del racconto.
Una delle questioni fondamentali affrontate da Sabrina Strings nel suo saggio sulla grassofobia (Fat Phobia, che ho tradotto per Mar dei Sargassi) ha a che fare con la dimensione narrativa del grasso. Il modo in cui i corpi delle donne grasse sono stati rappresentati e raccontati per secoli definisce il modo in cui tuttora i corpi femminili sono sottoposti a sorveglianza. E non solo: in questa storia a contare è soprattutto il fatto che non erano le donne soppesate sulla bilancia dell’estetica a raccontare di sé.
Ancora oggi, parlare di corpi grassi costituisce un tabù e ogni discussione sul corpo tende ad accompagnarsi a toni ora pietosi ora moraleggianti. Ancora oggi, nonostante dei passi avanti siano stati fatti, si affronta il tema dei disturbi alimentari con la superficialità di chi separa quello che succede dentro da quello che succede fuori di noi. Ecco perché assume un’importanza ulteriore occupare, come fa Balena, con il corpo e con le parole il campo ostile di una narrazione che ci vuole ancora omologate e sottomesse a un unico modello d’esistenza.
Il memoir si apre su una scena tragica: la Giulia bambina che dorme occupando con il corpo lo spazio del padre nel letto, mentre lui perde la vita in un incidente automobilistico. Nel libro, l’elaborazione della perdita di tuo padre è centrale. Mi ha molto colpita, leggendo, una frase, perfetta nella sua semplicità: Più lo ricordo sbagliato, più lo sento vivo. Com’è, oggi, il tuo rapporto con il ricordo?
«Nel disclaimer iniziale di Balena scrivo: questa è la mia verità, per quanto si possano considerare veri i ricordi. Con quelli che ho di mio padre ho sempre avuto un rapporto strano, nel senso che di lui non ho mai sentito troppi racconti se non da mia mamma. E, ancora oggi, quando tiro fuori un ricordo su mio padre, dice “no, non è andata così”: è in continua rimozione dei miei ricordi. Ormai è una gag fra noi due. Mentre io adoro ricordare i suoi errori, mia madre li ha scordati tutti. All’inizio, ho cercato di scacciarli via, i ricordi. Più lo ricordavo, più mi mancava. Poi, però, ho iniziato a mettere insieme i pezzi alla ricerca di qualcosa, soprattutto dei suoi disturbi, di quello che lo rendeva più strano. Mi sentivo molto sola e pensavo che lui fosse l’unica persona al mondo in grado di colmare quella mia solitudine, perché eravamo simili. Nella sua malinconia, nel suo dolore, più crescevo e più mi ritrovavo. Mi vedevo simile a lui non solo perché cercavo di ricreare in me il suo corpo, ma anche nei modi di reagire.
Mio padre era una figura stranissima, era difficile vederlo umano. Fisicamente era un uomo enorme: quando veniva a prendermi a scuola, vedevo la sua testa svettare sopra quelle di tutti gli altri genitori. Faceva cose matte, nel libro ne racconto solo alcune. Era difficile mantenerlo vivo e vero. Come potevo ricordare vero qualcuno che era stato così… cinematografico? Attraverso i suoi errori. Che poi, fa ridere, ma alcuni, uguali, li ho fatti anch’io. Il mio rapporto con il ricordo oggi è molto tenero, trattengo quello che c’è di più dolce nella nostra storia. Sono una figlia che vive tutti i giorni la mancanza. Non mi è mai passata».
 Giulia Muscatelli parla di Balena come se fosse un’altra persona, una parte di sé completamente distinta. Un’identità creata come insulto dalle compagne di classe, l’epiteto scagliato per offendere il corpo adolescente di Giulia, Balena diventa un suo alter ego, l’esemplare di un’altra specie arrivata a scompigliare le carte nella sua vita. Un po’ come il caro, imprevedibile padre. L’epigrafe all’inizio del libro riporta una citazione di Miguel de Cervantes: le tristezze non furono fatte per le bestie, bensì per gli uomini; ma se gli uomini ne soffrono troppo, diventano bestie. Nel corpo di Balena (balena cetaceo, Balena nome proprio) la scrittrice colloca la sua sofferenza e quella di un padre simile a lei in tutto. La pancia di Balena, come nell’adattamento Disney di Pinocchio, è luogo di ricongiungimento. Il travestimento avviene, nella vita di Giulia, metaforicamente e praticamente, quando, a una festa in maschera, decide di presentarsi vestita da “grande pesce marino”:
Giulia Muscatelli parla di Balena come se fosse un’altra persona, una parte di sé completamente distinta. Un’identità creata come insulto dalle compagne di classe, l’epiteto scagliato per offendere il corpo adolescente di Giulia, Balena diventa un suo alter ego, l’esemplare di un’altra specie arrivata a scompigliare le carte nella sua vita. Un po’ come il caro, imprevedibile padre. L’epigrafe all’inizio del libro riporta una citazione di Miguel de Cervantes: le tristezze non furono fatte per le bestie, bensì per gli uomini; ma se gli uomini ne soffrono troppo, diventano bestie. Nel corpo di Balena (balena cetaceo, Balena nome proprio) la scrittrice colloca la sua sofferenza e quella di un padre simile a lei in tutto. La pancia di Balena, come nell’adattamento Disney di Pinocchio, è luogo di ricongiungimento. Il travestimento avviene, nella vita di Giulia, metaforicamente e praticamente, quando, a una festa in maschera, decide di presentarsi vestita da “grande pesce marino”:
«È stata una delle mie idee geniali. Ero veramente convinta di essermi vestita da delfino. Nel libro, trattandosi di una rielaborazione dei ricordi, ho pensato che quello potesse essere il modo per dire “sono come dite voi, sono una balena”».
In quest’epoca in cui siamo tutti abituati a travestirci da altro, online, in che misura adottare un travestimento è fingere di essere qualcosa che non si è e quanto, invece, ci aiuta a rivendicare un’appartenenza?
«Credo di aver affrontato entrambe le fasi, sia quella in cui fingevo di essere altro (perché dopo Balena ho finto per tanto tempo), sia quella in cui rivendico con orgoglio la Balena. Credo siano entrambe molto faticose, come modi per affrontare la propria identità. Forse, però, la prima richiede anche molta più sofferenza. Nel tentativo di apparire sempre diverso da ciò che si è, più brillante, migliore, ci si stanca moltissimo. Io ho finto a lungo di essere una tipa spavalda. Nella seconda via, quella di essere finalmente ciò che si è, di appartenere a un’altra specie, hai la leggerezza della verità e dell’estrema onestà e con esse il rischio di non piacere agli altri. Che poi è anche il rischio di fare un libro così. È legittimo che agli altri tu, nella tua più vera identità, possa non piacere. Certo, non corri il rischio che possano non crederti, perché la scelta dell’autenticità arriva dopo un percorso, un lavoro su te stessa. Però molti potrebbero non voler ascoltare la tua storia, non voler guardare ciò che sei veramente e devi scendere a patti con questo.
Balena sta piacendo moltissimo e, online, la reazione delle persone è stupenda. Però, mi è stato riportato che qualcuno è andato a dire altrove, su altre pagine, che è facile, adesso che ho questo aspetto, raccontare la mia storia. Questa cosa mi fa imbestialire. La storia editoriale di Balena è stata così lunga anche perché io non volevo che apparisse come un libro così: il libro di una che prima era cicciona e poi è dimagrita. Perché non è questo che voglio raccontare, perché odio quel tipo di storia e perché non volevo aggiungerne un’altra alla marea di storie così che già esistono. Il mio è anzitutto un libro sull’elaborazione del lutto e poi, sì, anche sul corpo. Quindi quel tipo di commento mi fa rabbia perché non prende in considerazione come mi sono sentita, non capisce che vado nella direzione opposta».
Ritorna, così, l’occhio vigile della società, che passa al vaglio le esperienze altrui stabilendone i parametri di validità sulla rigida base di un canone – morale ed estetico – da rispettare. Ecco, ancora, che l’azione di raccontarsi Balena, specie altra, distrugge la cortina di una vergogna imposta. Il corpo al quale la parola scritta restituisce lo spazio, andava coperto, emarginato, deriso quando Giulia era adolescente.
«Il mio pudore nascondeva un senso di inadeguatezza, la vergogna per quello che era il mio corpo, come apparivo fuori. Però non era mai derivato da me, in realtà. Erano gli altri che me l’avevano appiccicata addosso. Come racconto, se le persone non avessero detto a Balena che era inguardabile, brutta, schifosa, lei non si sarebbe sentita così».
Balena subisce bullismo. Il suo corpo è oggetto di scrutinio costante da parte di professori e compagni di classe, che tentano di sorvegliarlo e contenerlo attraverso l’offesa. Un tema, nel modo in cui la società grassofobica si esprime, è certamente quello di tramandare questo istinto alla sorveglianza e al monitoraggio dei corpi fin dalla tenera età. Balena si trova a dover fare i conti con questo quando la storia della tv italiana vive la rivoluzione dei reality show. Oggi, un impatto certamente più forte lo danno i social, anche se cerca di farsi spazio una tendenza body positive…
«Io sono stata adolescente nel boom di Mediaset, che ha significato veline e Ciao Darwin, ma anche Wanna Marchi. L’altro giorno guardavo il documentario su Netflix: ho dovuto fermarmi alla seconda puntata, perché non ne potevo più di ascoltare i suoi commenti sui corpi. In quegli anni ci propinavano le veline di Striscia la notizia e le clip di questa qui che ti dava della lardosa e ti diceva che facevi schifo. Cosa potevamo tirarne fuori? Che facevamo schifo se non eravamo come loro. È questo il problema dei corpi grassi e questo è stato il problema mio, il problema di Balena: il mondo intero ti dice che per essere felice devi essere magro».
E i reality tipo Vite al limite?
«Feccia televisiva. Però, perché fa ascolti? Perché siamo contenti di non essere così: lo guardiamo e pensiamo “poveraccia, tutto sommato non sono così grassa, non posso lamentarmi dei chili di troppo”. È una sorta di conforto per noi stessi. E c’è grande superficialità nel modo in cui viene affrontato l’argomento. Spesso si tratta di persone che soffrono di un disturbo psicologico, prima ancora che alimentare. Oggi le cose sono certamente cambiate, c’è più attenzione, ma neanche poi così tanta.
Ti faccio un esempio: sono stata a comprare un paio di collant. Io sono alta 1.75 m e peso fra i 75 e gli 80 kg, non ho un corpo che rientra nei canoni classici di magrezza, nonostante ci raccontino il contrario con le campagne pubblicitarie inclusive. La commessa mi ha chiesto che taglia volessi e io le ho chiesto se avessero la quinta. Lei mi fa: “No, la quinta qua non la facciamo e poi guarda che la quarta copre fino a 80 kg: mi sembra che ti possa bastare”. Mi trovavo nel punto vendita di una grande catena ed è agghiacciante che un gruppo così importante non faccia taglie più grandi. Pensano che le donne si fermino a 80 kg? E da lì, poi, cosa deve succedere? Le altre non indossano i collant? Mi fosse capitato quindici anni fa, non sarei uscita di casa per tre giorni. Spesso si giustificano con un discorso sulla produzione: non conviene produrre per una piccola nicchia di mercato, ma la realtà è un’altra. È una questione legata a un problema culturale.
Il movimento body positive sui social è un pasticcio. Lo dico anche in Balena: se devo essere libera di mostrare il mio corpo così com’è, allora se postassi una foto di me in costume, una foto in cui si vede la cellulite, non dovrei sentirmi in dovere di scrivere una caption su quanto me ne freghi poco della cellulite perché siamo libere di mostrarci come siamo. Dovrei scrivere, piuttosto, quant’è bello il mare o che so io, come fa Belén Rodriguez. Invece sono obbligata a dare un messaggio di empowerment perché in fondo so che il mio corpo è considerato sbagliato. La libertà totale che pensiamo di avere è vacillante.
A me è capitato di avere delle discussioni con persone che si occupano di questi argomenti e dire che non indosso una minigonna da quando avevo sette anni perché le mie gambe non mi piacciono. E mi dispiace non aver superato questa questione con il mio corpo, però è così. Non mi posso sentire sbagliata per questo. Non mi si può accusare di non essere abbastanza libera o femminista perché non riesco a indossare la minigonna. Il punto d’arrivo dovrebbe essere che nessuno va giudicato per le scelte personali rispetto al proprio corpo. Sarebbe bellissimo se non ci riguardasse. Lo stesso che con l’orientamento sessuale. Qualcuno è eterosessuale, qualcuno è omosessuale, qualcuno è bisessuale: non dovrebbe far parte della nostra biografia».
Occupare spazio viene considerata una presa di posizione da condannare, soprattutto quando una donna è grassa. Raccontando la tua storia, che è anche la storia del tuo corpo, diresti che la parola può costruire per il corpo nuovi spazi da abitare?
«La mia esperienza di Balena ha effettivamente inciso sulla mia carriera. Voglio scrivere dall’età di sei anni, ma per molto tempo ho creduto di non potermi nemmeno sognare che esistesse un libro con il mio nome sopra. È una strada complicata, perché è complicato riuscire a raccontare quello che vuoi, come vuoi, con le persone giuste. Balena, infatti, ha una storia editoriale lunga (sette anni) perché, finché non è arrivata da nottetempo, era una cosa diversa. Non era un memoir: era un romanzo in terza persona. Poi, insieme alla editor, abbiamo avuto l’intuizione che questa storia aveva bisogno di avere la forma che ha adesso. Mi è stato fatto notare con una domanda semplicissima: “Ma perché no?”. All’inizio mi opponevo: chiunque scriva comincia raccontando la propria storia e io non volevo. Quando mi capitava di farlo leggere, la proponevo come una storia inventata. La domanda “perché no?” mi ha spiazzata perché non sapevo rispondere. Ora credo che la risposta sia che scrivere e pubblicare un libro è comunque occupare uno spazio, anche fisico, nella libreria delle persone. E io sono prima di tutto una lettrice, amo la letteratura e tutto ciò che ha a che fare con le storie e quando si ama una cosa così tanto la si rispetta. Quindi mi chiedevo: “sarò mai degna di stare negli stessi luoghi in cui abitano le scrittrici che amo?”.
Pensavo che raccontare la mia storia fosse troppo, a chi avrebbe potuto mai interessare. Per anni mi sono allenata al desiderio di raccontarmi, che mi era stato sempre negato. Ora, dopo aver letto il libro, in tanti mi dicono che è un libro coraggioso, ma io in realtà non ho trovato difficoltà a dire quello che ho detto. Prima di arrivare a scrivere, ho risolto a livello personale ciò che racconto, altrimenti il lettore, poveraccio, avrebbe dovuto farmi da psicanalista. E non sarebbe stato corretto. Spero che i lettori e le lettrici si appassionino a Balena indipendentemente dal fatto che si tratti di una storia vera. La bontà di un’opera deve prescindere da questo».
Immagine di copertina di Federico Botta©