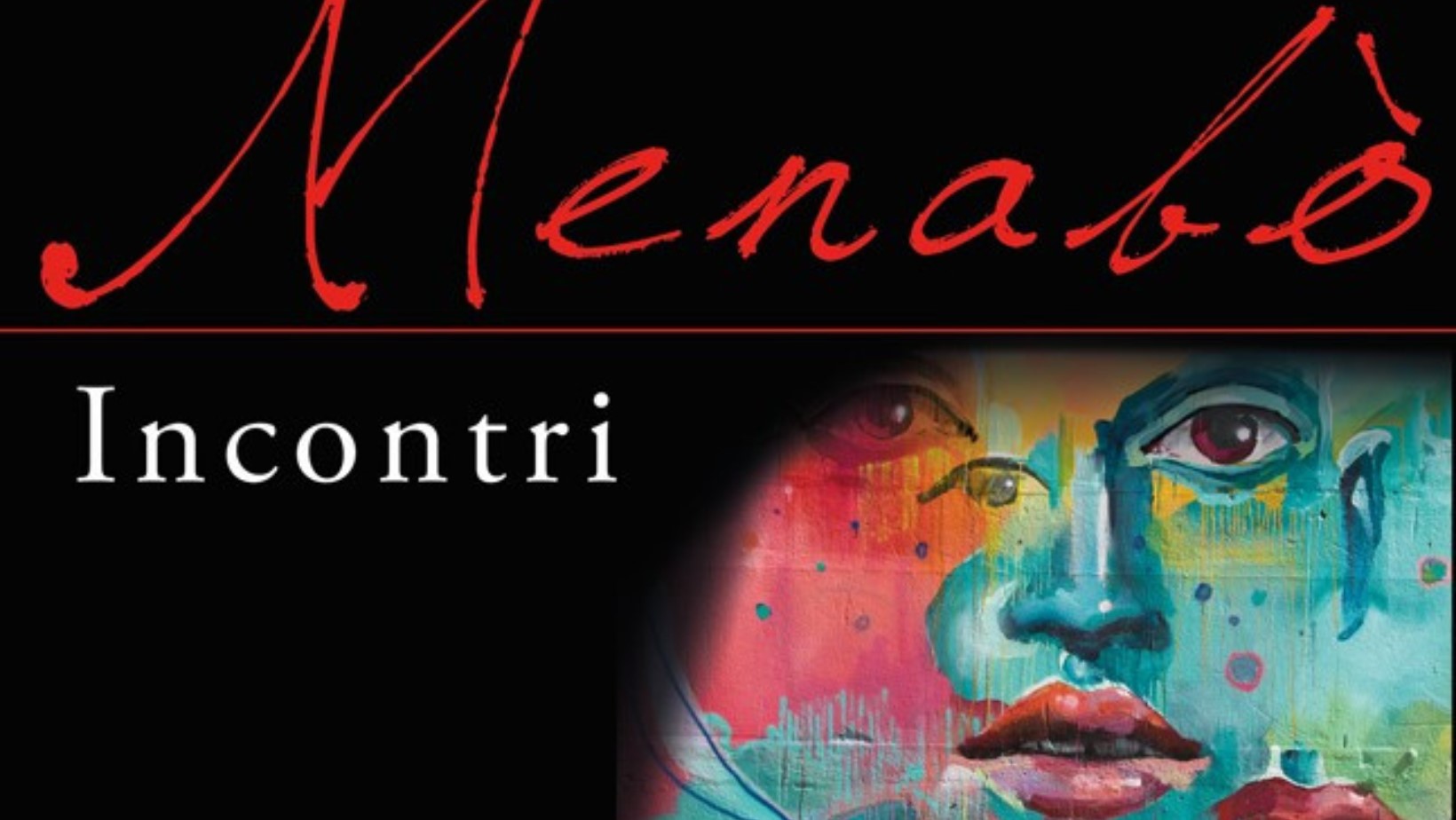C’è sangue ovunque nella casa gialla. Paul, che di cose ne ha viste, non crede ai suoi occhi. Atterrito, vede Vincent morente, con l’orecchio reciso che non smette di sanguinare.
È il passo decisivo che porta Van Gogh al ricovero, in una consapevole e ferma scelta: le sue crisi, il suo autolesionismo, la sua angoscia, sono frutto di una pazzia che va curata e con ogni mezzo. Vincent è stanco, sopraffatto dalle emozioni di una vita intera, annientato dall’incomprensione di troppi. La sua arte non vende, la sua vita sa trovare davvero pochi conforti: la sua pittura, che è anche il suo tormento, l’assenzio, che lo consola ma aggrava anche i suoi sintomi, e il fratello minore Theo, che lo mantiene e per il quale lui si sente un peso.
Quando viene ricoverato, il pittore scopre di essere affetto da epilessia, alcolismo e schizofrenia, ma le diagnosi non sono decisive e la ricerca medica continua, per anni, anche molto tempo dopo la sua morte. Per Jaspers è schizofrenia, ipotesi avvalorata da episodi paranoidi, come quello che lo porta a temere che i propri vicini vogliano avvelenarlo. Arnold, invece, rivede nei sintomi del pittore una malattia ereditaria di cui egli stesso è affetto: la porfiria acuta intermittente, patologia che alterna periodi di benessere ad attacchi improvvisi, disturbi fisici e allucinatori, e si manifesta in età avanzata.

Ma il “pittore pazzo”, da sempre taciturno e solitario, si distingue per le sue stranezze fin da giovanissimo. All’età di ventotto anni il suo cuore arde di passione per la cugina Kate, vedova con un figlio, la quale, però, non lo ricambia. Vinto dal dolore del rifiuto, il ragazzo si brucia la mano, in una sorta di pegno: l’avrebbe rivista grazie al suo gesto estremo. Ovviamente questo non avverrà mai e, ancora una volta, i sogni di colui che sperava di cambiare il mondo vengono infranti.
Vincent deve fare i conti con una realtà che sembra apparire troppo grande e che egli stesso prova a riversare nelle sue opere, capolavori che pochissimi contemporanei d’avanguardia sanno apprezzare.
Secondo alcuni, la prova della sua follia è da ricercare proprio nella pittura, compulsiva, fatta di pennellate irregolari, spesso satura di colori troppo intensi. È il giallo l’imputato più importante, segno di una visione distorta, prova di allucinazioni visive.
Nessun dubbio che il mondo visto dagli occhi dell’artista avesse un aspetto tutto particolare, diverso. Eppure, il confine tra il diverso e il folle è labile, si valica spesso e arbitrariamente. Non ci si chiede quasi mai se quel mondo non sia semplicemente più ricco, intriso di un senso che solo a pochi è dato cogliere: i sensibili nel profondo, quelli che hanno imparato – o sanno da sempre – guardare. Lo sapeva anche lui, che affermava, forse con fierezza: La natura è il miglior modo per comprendere l’arte; i pittori ci insegnano a vedere.
Ed è proprio la natura uno dei soggetti preferiti da Van Gogh: con tratti inconfondibili riporta sulla tela girasoli, cieli stellati, intere distese di grano, dove spesso ama fermarsi a dipingere e in cui, soprattutto negli ultimi anni della sua vita, non ha difficoltà, come egli confessa, nel cercare di esprimere la tristezza, l’estrema solitudine.
Soffre di depressione, Vincent, e, nei suoi disperati tentativi di porre fine alla sofferenza, tenta più volte il suicidio. Nel dicembre del 1889 ingerisce colori velenosi, e da allora gli viene vietata la pittura a olio. Il 27 luglio 1890, di ritorno dalla solita uscita per dipingere, sale nella sua stanza con un colpo di rivoltella nel petto, ferito a morte. Prima di andarsene, poche spiegazioni e una lettera in tasca, per Theo: Vorrei scriverti molte cose ma ne sento l’inutilità. […] Per il mio lavoro io rischio la vita e ho compromesso a metà la mia ragione.
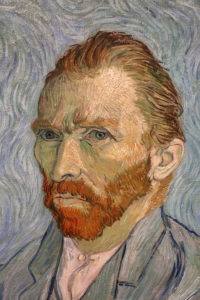
Una lucidità che da un folle non ci si aspetterebbe, ma che invece appare in Van Gogh. Le analisi che continuano a interessare il suo caso, sono l’imprescindibile indizio da cui partire se si vuole affrontare una figura tanto enigmatica, artista criptico anche per se stesso. I numerosi autoritratti non denunciano solo la consapevolezza che il nostro volto muta in accordo alle emozioni che esprime, alla vita che affronta, ma rappresentano il disperato tentativo di cogliersi, lo sforzo costante di riuscire a scoprire qualcosa di sé, guardandosi da spettatore esterno. Tuttavia, in questa ricerca, almeno fin quando è in vita, il pittore è pressoché solo: È come avere un gran fuoco nella propria anima e nessuno viene mai a scaldarvisi, e i passanti non scorgono che un po’ di fumo, in alto, fuori del camino e poi se ne vanno per la loro strada.
La sua pazzia, allora, non potrebbe essere stata una richiesta di aiuto, un ultimo doloroso tentativo di non sprofondare nel buio della solitudine e dell’abbandono? È la domanda che si sono posti gli organizzatori dello spettacolo Vincent Van Gogh nel Manicomio di Saint Paul, un dialogo serrato tra Vincent Van Gogh e la suora che lo assiste in manicomio, un dialogo alla ricerca del valore dell’arte, del senso della vita, dell’esistenza di Dio. Uno spettacolo che prova a riscrivere, o quantomeno a rivedere, la storia di un grande incompreso, che, come tutte le anime rare, è dalla nascita segnato da un destino infausto: essere avvolti da una gloria immensa quando ormai non si può più goderne.
Tutto ciò che Van Gogh non ha raccontato nel suo epistolario, si può solo immaginare. Recarsi alla Basilica di San Giovanni Maggiore, a Napoli, dal 24 novembre e poi per tutti i venerdì fino al 23 febbraio, può essere un modo per provarci. Ed ecco una nuova, vecchia domanda: cosa – e soprattutto chi – può definire il confine tra genio e follia?