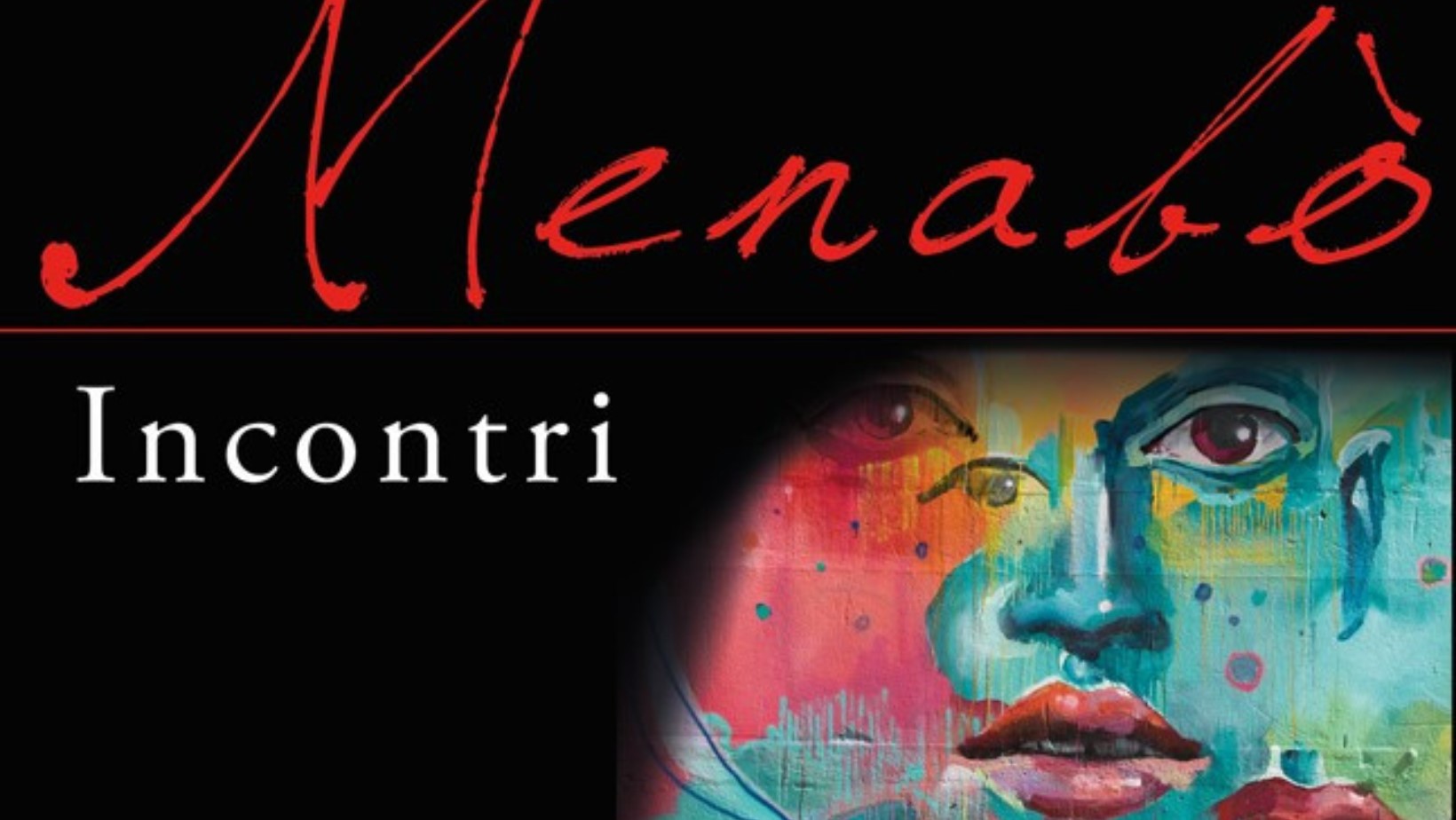Fine primo tempo, le luci si riaccendono. Mi alzo dallo sgabello e mi dirigo svelta verso i bagni delle donne. Spero di arrivare per prima, non ho voglia di vedere gente. Misteriosamente a teatro gli spettatori si conoscono sempre tutti, si salutano, visto che bella rassegna quest’anno? E la funicolare che non va, e il parcheggio che non si trova, le prime impressioni sullo spettacolo. Non mi piacciono le chiacchiere di circostanza, soprattutto quando la mia testa è rapita altrove e vuole restarci. Purtroppo c’è una coda lunghissima: mi immetto nel flusso, aspettandomi di essere avvolta dal consueto ciarlare delle signore. Invece, c’è un silenzio innaturale.
Nessuno parla. Mi guardo attorno e intercetto qualche sorriso imbarazzato, al massimo un paio di saluti frettolosi. Al più gli sguardi sono a terra: ogni tentativo di sdrammatizzare cade nel vuoto, c’è qualcosa che gela l’atmosfera. Siamo a disagio, e la cosa mi sorprende. Nessuno di noi ha più lo stomaco delicato, gli ultimi anni di guerre e pandemie ci hanno anestetizzati. Abbiamo imparato a mandar giù riprese di cadaveri tra una pasta al sugo e uno spezzatino, e ci siamo abituati a leggere la morte attraverso grafici e posti letto liberi in ospedale. E allora che succede? Sembriamo i testimoni di qualche crimine atroce radunati nella sala d’attesa di un commissariato. Quello che abbiamo visto ci ha bruciati.
Torno in platea pensando che vorrei averla scritta io, un’opera in grado di resistere alla leggerezza delle toilette femminili. Invece, l’ha fatto Mimmo Borrelli con La Cupa – Fabbula di un omo che divinne un albero. Si tratta dello spettacolo d’apertura del Teatro Bellini di Napoli, che tornerà in scena dal 2 al 13 novembre.
Disclaimer: tutto quello che scriverò, da ora in poi, sarà un’eco flebile di ciò che ho visto. Non potrò mai ricreare l’atmosfera misterica e brutale di questa sera, né le musiche infernali, le bestemmie, le urla e canti strazianti. Beh, forse le bestemmie sì, ma non sarebbero in grado di farvi attorcigliare le viscere. Voglio provare, però, a spiegare quel silenzio in fila alla toilette.
La nostra storia inizia in una notte di metà gennaio, quando di colpo il buio viene acceso da enormi falò. È la festa di Sant’Antonio, patrono delle bestie e del fuoco. Secondo le leggende, in questa gelida notte gli animali acquistano facoltà di parola e concetto. Nessun uomo deve avvicinarsi alle stalle, perché ogni prodigio ha un prezzo: chiunque ascolti le parole delle bestie verrà perseguitato da discordia, sfortuna e dispetto. Non vi meravigliate, dunque, se andando a teatro sentirete una papera e un maiale parlare, è un miracolo concesso. Scoprirete che le voci degli animali saranno le uniche a conservare un briciolo di umanità e giudizio, mentre quelle degli uomini saranno ringhi bestiali.
Troverete il teatro diviso in due da una lunga pedana nera. Le poltroncine, di solito sistemate ordinatamente per tutta la platea, sono state addossate alle pareti per far spazio alla navata scura. Su di essa, corrono e danzano uomini e bestie. Non è altro che la rappresentazione di una cupa, una stradina stretta, incassata e buia che attraversa la campagna flegrea. Alla fine del viottolo c’è una voragine profonda, una cava di tufo proprietà di Giosafatte ’Nzamamorte, colui che frega la morte. ’U monte: così vengono chiamati i promontori in tufo dei Campi Flegrei che si estendono da Torregaveta al Fusaro. Ai tempi dei romani, ’u monte è stato perforato, svuotato con avidità per ottenere materia prima.
Negli anni Novanta, molte cave di tufo sono diventate discariche della camorra, perfetti nascondigli in cui riversare liquami tossici e scorie nucleari. E così anche la cava di ’Nzamamorte, contaminata da rifiuti radioattivi e cadaveri di bambini privati dei loro organi. Nessuno dei cavatori e dei camorristi lì insediati è innocente, ognuno ha seppellito nel profondo della cava qualcosa di orrendo. Madre terra viene insozzata e stuprata dai suoi stessi figli, che non si accorgono di avvelenare anche se stessi: quella flegrea è tra le zone della Campania con il più alto tasso di mortalità e malformazioni. Nonostante tumori e decessi, non c’è pentimento: durante il lockdown, le ecomafie hanno aumentato esponenzialmente i crimini ambientali in tutto il Paese.
In un territorio avvelenato, ogni relazione diventa tossica. Le radiazioni creano mutazioni mostruose nella natura umana: la sessualità devia verso la pedofilia e l’incesto, le famiglie mutano in ceppi virulenti, la rabbia si trasforma in stupro e omicidio. Nella notte in cui gli animali prendono la parola, gli uomini regrediscono a bestie, mossi solo dai loro istinti più bassi. Consumano la montagna, mentre la montagna consuma loro. Ogni legame d’affetto si corrode e corrompe, la paternità – fulcro di tutto il testo – si rivela impossibile di fronte a una società cannibalistica che sta distruggendo se stessa.
Ma ’a terra primma o poi ’nt’ ’a na vota / contr’a ll’ommo sempe s’arrevota. In questa storia, la montagna e la cava non rimangono mute e immobili. Dopo aver ingurgitato per anni scorie e liquami tossici non possono fare a meno di vomitarli: una enorme frana cade su camorristi e cavatori, riportando alla luce tutto ciò che è nascosto. Il crollo è ribellione: stupro, incesto, pedofilia, uxoricidio, parricidio – la distruzione è l’unico epilogo possibile. Se un tempo ero disposto a morire, / figlia mia, pe’ cagna’ li ccose, mo’ pecché / non dovrei essere disposto a vivere / ancora un poco pe’ farle muri’ cu mmé. Una pioggia di liquami tossici si abbatte su ’Nzamamorte, che subisce l’ultima metamorfosi dell’opera: quella in una creatura di resina e corteccia. L’unico modo di uscire dalla tragedia è il cambiamento di stato.
Nelle sue note di regia, Borrelli scrive che alla fine questo testo parla di cose enormemente attuali […] argomenti del tutto esposti alla realtà del presente, ma rispetto ai quali non sentiamo e percepiamo più orrore, avvinti come siamo da quell’assuefazione, dovuta al lucro dei mezzi televisivi e telematici che tali notizie diffondono.
Ed è vero: non sentiamo più. Giornali, radio, televisioni e istituzioni hanno pensato che fosse una buona idea imporre un continuo terrorismo fatto di bollettini di guerra e tabelle di infettati, morti e intubati. Ma una comunicazione militarizzata e bombardante ha delle implicazioni psicologiche e sociali: siamo in un costante stato d’allarme e, quindi, non lo siamo mai. Il telegiornale passa la foto di una donna sorridente e dice che è stata fatta a pezzi dal marito. La prima volta ci inorridisce, poi diventa una delle tante. La sua storia verrà accorpata in qualche curva esponenziale sui femminicidi, o raccontata in uno squallido programma pomeridiano in tutti i suoi macabri dettagli, e perderà di significato.
È la diffusione costante – ma soprattutto superficiale e deumanizzante – di storie simili che ce le fanno diventare normali, perché diventano norma, linguaggio comune. Non riusciamo più a sentire l’orrore perché da questo marasma di informazioni e dettagli cruenti non riusciamo a ricavare un senso. Tra uno spot e l’altro ci appare un bimbo africano con il corpo scheletrico e la pancia gonfissimo: non ci scopriamo una correlazione – tra povertà e pubblicità di lusso – ma anzi, accettiamo la coesistenza di questi due elementi come endemici al palinsesto televisivo. Manca un sistema di coerenze, aderenze e appigli, fisici e concettuali, che ci permettano di costruire e trovare senso.
Questo è forse il problema culturale più grande del nostro secolo. Non siamo in grado di sentire nella carne ciò che accade, né di comprendere appieno ogni correlazione di un mondo globalizzato e iperconnesso. I nostri bias cognitivi ci impediscono di capire che minacce complesse come l’olocausto nucleare o la crisi climatica non sono delle apocalissi inevitabili e senza agenti, ma dei processi continuativi profondamente legati al nostro intervento. Se solo ce ne accorgessimo, se lo sentissimo nello stomaco e non nella testa, invertiremmo di corsa la rotta.
Torniamo per un attimo a quella fila silenziosa di fronte alla toilette. In una coda estremamente eterogenea, tutti abbiamo sentito qualcosa. L’arte, quella fatta bene, è in grado di compiere un piccolo miracolo: dire la verità. Basta che siano veri il dolore, la rabbia, la sofferenza e l’odio di chi è sul palco, che diventa vero tutto ciò che ci sta accadendo sopra. Se sono vere le urla strazianti, le lacrime e la rabbia, allora è vero lo stupro ed è vera la morte. All’inizio scherzavo sul fatto che sembrassimo tutti testimoni di un crimine, ma lo siamo stati davvero: non abbiamo subito la semplice cronaca di un fatto cruento. Lo abbiamo visto accadere.
Sapevamo che nei territori di Bacoli e Torregaveta c’erano discariche nascoste. Sì, ma stavolta ne abbiamo visto le conseguenze devastanti su degli esseri umani a meno di un metro da noi. Ho citato più volte, in questo articolo, Salvatore Iaconesi, una guida che porterò sempre con me. Uno dei suoi mantra era: serve la sofferenza per togliere la mano dal fuoco. Cosa vuol dire? Che quando ci scottiamo, impariamo che quella cosa brucia, e non lasciamo che i nostri arti si carbonizzino perché anestetizzati.
L’arte deve servire a questo: creare qualcosa di forte come una scottatura, per farci levare la mano dal fuoco. Deve aumentare a dismisura la nostra sensibilità, esponendoci alla tragedia, al dolore, e alle fragilità umane, dell’ambiente, della biosfera, delle città e dei territori. Ed è esattamente ciò che fa Mimmo Borrelli, come attore e come drammaturgo.
Borrelli ogni volta sul palco si sacrifica. Perde litri e litri d’acqua e, per sua stessa ammissione, finisce con l’avere una colite due giorni dopo ogni spettacolo. Io cerco di essere vero in scena non per cambiare il mondo, quello sarebbe impossibile – racconta in un’intervista – ma la prossimità, quella prossimità che questo sacrificio ci ha violato. L’errore di tanti grandi gesti mediatici è che cercano di colpire le masse: invece, parlare alla prossimità è la chiave.
Ripassando la palla a Iaconesi, c’è bisogno di riconnettersi ai corpi, corpi che dovrebbero sentire il dolore di altri corpi, di animali, di piante, di città, e che, in virtù del sentire questa sofferenza, nel loro stesso corpo, non potrebbero fare a meno di trasformarsi. Solo riconoscendo la tragedia e sentendola nella carne avremo le forze di superarla, di operare quella trasformazione culturale e sociale necessaria per la sopravvivenza.
E tornando ancora a Borrelli – forse sembro matta, ma quasi mi pare un dialogo – il dovere di un cronista è narrare la realtà storica, il dovere di un poeta è emotivare la realtà storica. [..] il poeta ha il dovere di scrivere il proprio mondo per pensarne un altro diverso, riaprendone le ferite, intingendo il pennino nel sangue delle ferite umane.
Nulla di utopico o impossibile: le narrazioni sono ciò che danno potere al sistema corrente, senza di esse la società crollerebbe. I poeti hanno sempre animato rivoluzioni, e possono farlo ancora se ascoltano le voci del proprio popolo e territorio. Se qualcuno ti dice che sei un poeta – chiudo con Borrelli – hai il dovere di ascoltare quelle voci e darne testimonianza. E non testimonianza solo storica, ma testimonianza in corpo, in voce e in memoria.