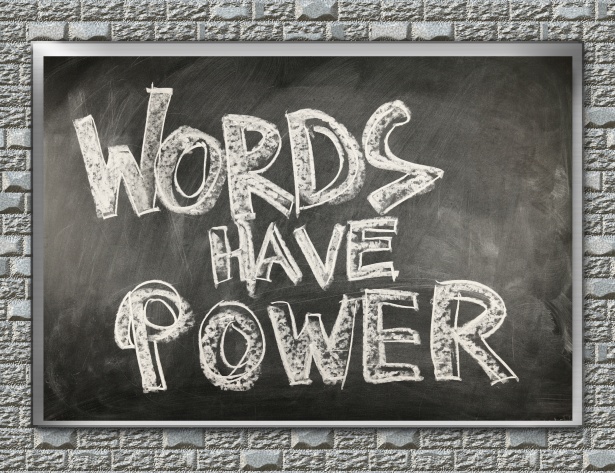Mentre i talebani serrano la loro presa su Kabul e le loro prime rassicurazioni di moderazione vacillano, l’Occidente osserva le immagini provenienti dall’Afghanistan e commenta con rammarico la propria sconfitta. Siamo tornati indietro di vent’anni, oppure li abbiamo cancellati. La storia del Paese martoriato dalla guerra compare ancora adesso, ancora una volta, come un capitolo infelice di una storia più grande, più importante – quella americana ed europea –, i destini di centinaia di migliaia di persone ridotti a una fotografia, quella di una donna col burqa o di un bambino piangente, con gli abiti impolverati e sporchi di sangue rappreso, che guardiamo con distacco paternalista.
Qualche giorno fa, le immagini degli uomini avvinghiatisi in un disperato tentativo di fuga ai carrelli d’atterraggio degli aerei militari americani per poi precipitare nel vuoto avevano rievocato tragicamente alla memoria l’immagine dei Falling Men che, per sfuggire all’inferno di fuoco e metallo delle Torri Gemelle, si erano suicidati lanciandosi dal grattacielo appena esploso. Ogni mattina, da un paio di settimane a questa parte, ad attenderci al tavolo della colazione c’è un bollettino dei civili dispersi, feriti o rimasti uccisi nelle proteste, nei tentativi di fuga, nelle epurazioni e nelle esplosioni che si sono avvicendate dall’annuncio statunitense dell’abbandono della missione in Afghanistan. Spettatori di morte eravamo allora, spettatori di morte siamo adesso. Con una sostanziale differenza.
L’immagine del crollo delle Torri Gemelle ci è rimasta stampata nel cervello non solo perché quel giorno si poneva fine con la tragedia all’illusione di invincibilità dello strapotere americano, sulla cui base si era modellato e si modella ancora il mito della società occidentale liberista: quello del World Trade Center era il primo vero avvenimento globale nell’era di internet. Intorno alla sua storia sono stati tessuti i primi complotti bisbigliati sui forum e sui blog, mentre i media tradizionali e addirittura l’industria dell’intrattenimento facevano da megafono alla propaganda bellicosa della war on terror. Oggi, le immagini che ci arrivano dall’Afganistan hanno vita diversa. Consumiamo le tragedie molto più in fretta, le accantoniamo in attesa dello shock successivo che, per fare notizia, deve essere sempre più forte. Scrolliamo i feed dei nostri social network affamati anche di questo: in attesa di condividere con gli altri non solo la nostra opinione non richiesta in materia di aiuti umanitari e politica internazionale, ma anche di provocare una reazione nel nostro minuscolo pubblico alla condivisione di una notizia o una fotografia che non possono lasciare indifferenti.
Su internet, oggi, non siamo fruitori passivi delle informazioni condivise da qualcun altro: siamo editori e censori di noi stessi, al punto da arrivare a influenzare la rilevanza dell’informazione anche a livello macroscopico. Così, accanto alle immagini di donne, uomini e bambini in fuga dal regime, assistiamo al replicarsi, sui social network, di meme raffiguranti talebani armati fino ai denti colti in attività goffe e infantili: mangiare il gelato, guidare le macchinine all’autoscontro, gigioneggiare con gli attrezzi della palestra presidenziale. Queste sono le immagini che hanno accompagnato le prime dichiarazioni dell’Emirato Islamico di stare perseguendo una via più moderata. Quelle foto si contrappongono a ogni manifesto strappato, ogni protesta sedata con la violenza, ogni giornalista perseguitato, ogni oppositore misteriosamente scomparso. La strategia è chiara: instillare anche solo il dubbio legittimo che i nuovi talebani siano diversi. L’immagine clownesca del leader che sa ridere di sé e si ridicolizza davanti agli altri raggiunge il doppio obiettivo di chetare la paura esterna della minaccia talebana e, al contempo, di controllare in che misura, in che modalità e a chi sia rivolta questa nuova immagine apparentemente innocua.
Mentre sulle nostre pagine Facebook ci scambiavamo, con l’emoji della risata, i meme di questi uomini dalle barbe folte e i fucili a tracolla immortalati con un cono gelato fra le mani, emergeva dai meandri della rete il video dell’arresto del comico afghano Nazar Mohammad, pestato, torturato e ucciso per averli derisi. Il video della sua cattura lo mostra prendersi gioco dei suoi aguzzini. Uno dei soldati a tenerlo fermo ride dentro la telecamera, mentre un secondo si volta a schiaffeggiare Mohammad con violenza. I portavoce talebani hanno ammesso che il comico avrebbe dovuto essere processato, non ucciso, come invece è stato, per iniziativa di un non meglio specificato gruppo di ribelli.
La rinnovata strategia mediatica si avvale dei social network e conta sulla viralità del messaggio e del contenuto per diffondersi. Da un’inchiesta di VICE, riportata anche su Rolling Stone in un articolo che si interroga sulla posizione che prenderanno Facebook et similia al momento dell’ufficializzazione del governo talebano, emerge come il gruppo fondamentalista avrebbe guadagnato rapidamente consensi a livello locale attraverso l’uso di WhatsApp e come l’invio di messaggi attraverso la piattaforma avrebbe permesso loro di coordinare la presa di Kabul. È recentissima la notizia diffusa da fonti BBC che i talebani abbiano tagliato ogni possibile accesso a internet e ai telefoni nella valle del Panshir, ultimo baluardo afghano di resistenza. La storia insegna, in fondo, che il modo più efficace di controllare l’informazione sia impedire l’accesso alle fonti.
Con tutte le differenze del caso, l’utilizzo dei social da parte dei gruppi di potere appare molto simile a quello che ne fanno i populisti in Europa e negli Stati Uniti. Non siamo nuovi alla patina friendly esibita da noti personaggi politici sui propri profili social, spesso dopo dichiarazioni pubbliche atroci e l’impegno quotidiano nella proposta o approvazione di norme disumane; né ci stupì, all’epoca, che i seguaci di Donald Trump avessero accarezzato e organizzato l’idea di assaltare il Campidoglio per sovvertire le elezioni presidenziali sulle chat di gruppo dei social network.
Le fake news viaggiano ogni giorno su un binario affollatissimo di meme e fotoritocchi, alimentando l’odio e la paura del diverso. Nel nostro ruolo privilegiato di fruitori di immagini, in quest’era in cui la nostra attenzione è il prodotto, siamo presi tra due regie diverse dello stesso film: da un lato, assistiamo al patetico pianto del coccodrillo occidentale che vive e racconta tutto in funzione di se stesso e, pure, non si esime dalla retorica del salvatore degli innocenti (ma attenzione: solo quando si tratta di donne e bambini); dall’altro, il nuovo volto di un vecchio nemico, tirato a lucido quel tanto che basta da non farci sentire in colpa se, in futuro, stringeremo ufficialmente patti e accordi con lui.