Ogni qualvolta partecipo a una presentazione di un libro di Marco Perillo o dopo averlo letto, mi torna alla mente quanto mi disse un giorno di qualche decennio fa lo scrittore Antonio Altamura subito dopo aver salutato il mai dimenticato giornalista e scrittore Max Vairo sull’uscio della sua casa di San Carlo alle Mortelle dove, nello stesso palazzo, ho vissuto la mia gioventù: «Vairo è scrittore e giornalista contrariamente ad alcuni giornalisti, anche scrittori, che scrivono di Napoli».
Marco Perillo è scrittore e giornalista, rigoroso e appassionato studioso della storia di Napoli, del suo patrimonio artistico e culturale, e in questa intervista – rilasciataci in occasione della prossima uscita del suo nuovo libro, Napùl, edito da Alessandro Polidoro Editore – ci racconta del suo nuovo corso letterario, un Marco Perillo diverso, forse inaspettato.
Da un romanzo tra storia, fede e archeologia in Phlegraios – L’ultimo segreto di San Paolo ai Misteri e segreti dei quartieri di Napoli. Dai 101 perché sulla storia di Napoli che non puoi non sapere alle Storie segrete della storia di Napoli, a I luoghi e i racconti più strani di Napoli, ora Napùl. Un viaggio cominciato da molto lontano, dalla bella terra flegrea, per immergerti poi nelle viscere del capoluogo campano e nella sua storia per approdare alla città di oggi. C’è una connessione in questo itinerario letterario?
«C’è senz’altro il fil rouge della narrazione di una terra complessa e ogni giorno diversa come quella partenopea. Una terra affascinante ed enigmatica che ci pone sempre di fronte a infinite domande. Da un lato la bellezza e la ricchezza storica, dall’altro alcune miserie del presente e problematiche sociali irrisolte, che appaiono più forti che altrove. Una terra di grandi contraddizioni, della luce e delle ombre, del bene e del male che si contrappongono nello stesso istante. Uno stimolo continuo per un narratore che si trova ad abitarla da sempre e che prova, per quanto può, a darsi delle spiegazioni attraverso il racconto. Se finora ho raccontato prevalentemente la bellezza, la storia, la fede, la leggenda, la tradizione – la faccia migliore della medaglia – adesso, con Napùl, mi trovo ad affrontare necessariamente la parte più dolente della città. Con la quale, prima o poi, avrei senz’altro dovuto fare i conti».
Quindici racconti su una città cui hai dato il nome di Napùl – in libreria dal 27 maggio –, un nome che sta a metà tra Napoli e Kabul. Perché?
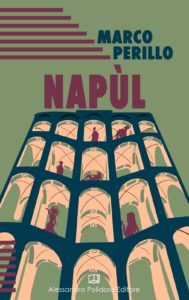 «Abbiamo vissuto anni di guerra, anche se forse non ce ne siamo accorti. La terza guerra mondiale, come l’ha definita Papa Francesco, combattuta a pezzetti. Alle soglie del 2000 si parlava di fine della storia. Si pensava che ormai davanti a noi si sarebbe spalancato un lunghissimo periodo di pace e di benessere. In parte è stato così, ma era un’illusione. E quel che è accaduto dall’11 settembre 2001 con la caduta delle Torri Gemelle fino ai più recenti attentati terroristici di matrice islamica in Europa ci ha messo di fronte all’amara realtà. La guerra non era affatto finita – per dirla alla Eduardo di Napoli milionaria – e continuava a casa nostra, facendoci vivere nell’insicurezza e nel terrore. Se per fortuna l’Italia non è stata attaccata dall’ISIS, la città partenopea si è rivelata essere un crocevia fondamentale per la diffusione del pericolo in Europa. Diverse connessioni tra i clan di camorra e i terroristi islamici sono emerse nel tempo in termini di rifornimento di armi, di passaporti falsi, di denaro sporco. Terroristi che hanno combattuto per l’ISIS sono stati trovati e arrestati nel Napoletano e addirittura una ragazza della nostra terra convertita all’Islam più radicale, Maria Giulia Sergio, si è scoperta la pericolosissima foreign fighter Fatima Az Zahara. Sarà difficile credermi, ma per me è stato sconvolgente aver “previsto” tutto questo in un racconto, l’ultimo della raccolta, lì dove parlo di uno scugnizzo dei nostri vicoli che a un certo punto, più per necessità che per convinzione, abbraccia la causa di Al Qaeda. L’ho scritto in tempi non sospetti, nel 2006, e mai avrei immaginato che una cosa del genere potesse accadere davvero, una decina d’anni dopo. La realtà che supera la fantasia. Eppure non deve sorprenderci. Napoli è sempre stata il lasciapassare per l’Oriente, una città più simile a una Beirut, a una Gerusalemme che non a una Berlino o a una Londra. E, nella fattispecie, più simile a Kabul, la capitale dell’Afghanistan bombardata nel 2001 perché tenuta in mano dai talebani. Una città in guerra quotidiana, in cui la lotta per sopravvivere è talvolta più dura che altrove. Specialmente oggi, che alle prese con il coronavirus la sensazione di vivere come in guerra si è notevolmente amplificata».
«Abbiamo vissuto anni di guerra, anche se forse non ce ne siamo accorti. La terza guerra mondiale, come l’ha definita Papa Francesco, combattuta a pezzetti. Alle soglie del 2000 si parlava di fine della storia. Si pensava che ormai davanti a noi si sarebbe spalancato un lunghissimo periodo di pace e di benessere. In parte è stato così, ma era un’illusione. E quel che è accaduto dall’11 settembre 2001 con la caduta delle Torri Gemelle fino ai più recenti attentati terroristici di matrice islamica in Europa ci ha messo di fronte all’amara realtà. La guerra non era affatto finita – per dirla alla Eduardo di Napoli milionaria – e continuava a casa nostra, facendoci vivere nell’insicurezza e nel terrore. Se per fortuna l’Italia non è stata attaccata dall’ISIS, la città partenopea si è rivelata essere un crocevia fondamentale per la diffusione del pericolo in Europa. Diverse connessioni tra i clan di camorra e i terroristi islamici sono emerse nel tempo in termini di rifornimento di armi, di passaporti falsi, di denaro sporco. Terroristi che hanno combattuto per l’ISIS sono stati trovati e arrestati nel Napoletano e addirittura una ragazza della nostra terra convertita all’Islam più radicale, Maria Giulia Sergio, si è scoperta la pericolosissima foreign fighter Fatima Az Zahara. Sarà difficile credermi, ma per me è stato sconvolgente aver “previsto” tutto questo in un racconto, l’ultimo della raccolta, lì dove parlo di uno scugnizzo dei nostri vicoli che a un certo punto, più per necessità che per convinzione, abbraccia la causa di Al Qaeda. L’ho scritto in tempi non sospetti, nel 2006, e mai avrei immaginato che una cosa del genere potesse accadere davvero, una decina d’anni dopo. La realtà che supera la fantasia. Eppure non deve sorprenderci. Napoli è sempre stata il lasciapassare per l’Oriente, una città più simile a una Beirut, a una Gerusalemme che non a una Berlino o a una Londra. E, nella fattispecie, più simile a Kabul, la capitale dell’Afghanistan bombardata nel 2001 perché tenuta in mano dai talebani. Una città in guerra quotidiana, in cui la lotta per sopravvivere è talvolta più dura che altrove. Specialmente oggi, che alle prese con il coronavirus la sensazione di vivere come in guerra si è notevolmente amplificata».
Quindici racconti sulla Napoli dei nostri tempi con i suoi problemi vecchi e nuovi e con le sue contraddizioni di sempre. Le piaghe – come le hai definite tu – di una camorra e di fenomeni nuovi di malavita che coinvolgono anche gli adolescenti, una camorra con agganci persino con il terrorismo islamico. È la narrazione di un’unica realtà con tutti i suoi aspetti negativi, come certa letteratura ci ha ormai abituati, o vi sono cenni di speranza?
«Come dicevo, la mia è stata una “discesa agli inferi” necessaria. Affrontare le piaghe, il dark side della città è stato un modo per esorcizzare con la scrittura a tutto quello che stava accadendo, che non mi piaceva affatto e che quotidianamente mi trovavo ad affrontare nel mio lavoro di giornalista. Una camorra che proprio negli anni che sono seguiti allo choc delle Torri Gemelle è tornata a sparare e ad ammazzare come non accadeva dai tempi di Cutolo – ricordiamo le faide di Secondigliano o la tragedia di Annalisa Durante e di moltissime vittime innocenti – seguita poi dal terribile cambio generazionale e dalla paranza dei bambini, nonché dal detestabile fenomeno delinquenziale minorile delle baby-gang. Proprio i più piccoli, i più fragili, sono stati coinvolti in quest’ondata criminale. Vittime innocenti a parte, come non ricordare i bambini costretti a confezionare se non a smerciare la droga, perché insospettabili? Infanzie rubate in nome del profitto becero della camorra. Gli ultimi anni sono stati proprio tosti, bisogna ammetterlo. Perché se da un lato i turisti sono tornati ad affollare e ad amare le strade della nostra città – e non è un caso che contemporaneamente io abbia prodotto saggi sulle nostre meraviglie –, nello stesso identico momento Napoli era stretta in una morsa criminale fatta di recrudescenza di armi, dall’illegalità diffusa, dai traffici internazionali di droga. Da una situazione di guerra quotidiana, come dicevo. Soltanto un anno fa ne abbiamo avuto prova col ferimento di una bambina in pieno giorno a piazza Nazionale, la piccola Noemi, colpita da un proiettile nel corso di un regolamento di conti. Tutto normale? Giusto vivere in una realtà del genere? Io sono uno di quelli che crede che il cosiddetto sputtanapoli non esista. Perché ci sputtaniamo da soli se certe cose accadono ed è impossibile non raccontarle. Roberto Saviano non ha avuto tutti i torti a scrivere Gomorra. Perché il suo intento primario, che ha fatto breccia anche in me, nasceva dalla stessa urgenza che ho avuto io: affondare le mani nel male per cercare di comprenderlo, di denunciarlo, di urlarlo con dolore. Il problema di Saviano, a mio giudizio, è che in seguito a questa sua autentica necessità narrativa sia scaturito il business e l’eccessiva spettacolarizzazione del fenomeno, la gomorreide, francamente eccessiva e controproducente, spesso fenomeno di emulazione da parte di giovani sbandati. Eppure, nei miei racconti, lascio spazio alla speranza. Perché se è vero che molti di questi sono un vero e proprio pugno nello stomaco – una definizione del compianto Sepúlveda, propria della forma-racconto, la cui missione, a differenza del romanzo, è esattamente questa –, in altri c’è chi ce la fa, chi dice no alla malavita, chi ha il coraggio di denunciare il proprio figlio tossicodipendente per salvargli la vita, chi affetto da un grave problema fisico affronta con dignità la vita nelle Vele di Scampia, chi riesce a sgominare un pericoloso produttore di soldi falsi per i terroristi. Per non parlare di un racconto in particolare in cui ridicolizzo un boss della camorra dall’inizio alla fine, mettendolo di fronte a tutti i suoi limiti».
Nelle tue precedenti opere hai raccontato dei misteri e dei segreti di Napoli, nei racconti del nuovo libro continua questa narrazione fatta di curiosità e di ricerca che ti ha sempre caratterizzato?
«C’è certamente un forte lascito. Perché Napoli, non essendo solo bene né solo male, è un miscuglio continuo. E, più che altrove, deve fare i conti col suo passato millenario, con la sua speciale stratificazione di storia e storie. Innanzitutto ogni racconto ha il titolo di una strada, di un quartiere, di un vicolo o di una piazza della città, in qualche modo evocativo di quel che accadrà. Il primo, Anticaglia, non a caso è un rinverdire in chiave moderna di un mito ellenico, quello di Medusa, tra le strade del nostro centro storico. Ed è, attraverso la storia di un novello Perseo alle prese con la Gorgone, un po’ la metafora e il messaggio principale di questa raccolta: essere capaci di affrontare i propri mostri, i propri demoni, le proprie paure. In una città in guerra, rispondere con un altro atto di guerra: quello del nostro orgoglio, del nostro coraggio, del nostro non tirarci indietro, per non farci pietrificare. Non restiamo immobili di fronte alle sfide della vita. Inoltre, se parliamo di racconti un motivo profondo c’è. Avete mai fatto caso che non esiste un vero e proprio grande romanzo su Napoli? Uno definitivo, dico. Che racconti tutto e che sia lo specchio della città. È impossibile. Perché Napoli è un caleidoscopio, come diceva Fabrizia Ramondino. E la forma del racconto, con le sue molteplici sfaccettature, è la forma migliore, insieme con quella teatrale, per narrarla. Io lo faccio con una lingua ibrida, a metà tra il dialetto e l’italiano, molto aderente al presente. Tenendo presente la grande tradizione del racconto napoletano, da Matilde Serao a Salvatore Di Giacomo, passando per Domenico Rea e arrivando ai più recenti Andrej Longo, Peppe Lanzetta o Valeria Parrella. Sono questi i modelli cui, più o meno, mi sono ispirato. Sperando che il tutto si possa leggere come un romanzo. Perché i singoli racconti, da soli, non avrebbero avuto la stessa forza dell’essere messi assieme. E per fortuna un lungimirante e coraggioso editore come Alessandro Polidoro lo ha capito, dandomi la possibilità di pubblicare questo libro. A lui va il mio grazie perché in un momento in cui l’editoria italiana snobba i racconti – cosa direbbero i Carver, gli Hemingway, ma anche i Buzzati o i Tabucchi? – sta dando grande spazio a tale forma narrativa. Con una squadra di giovani davvero in gamba – Antonio Esposito, Adriano Corbi, Cecilia Laringe e Beatrice Morra – stanno facendo letteratura di qualità e non è un caso che stiano avendo molto successo nelle fiere in giro per l’Italia, riscontri notevoli nelle librerie soprattutto del Nord e una grande efficacia per quanto riguarda la presenza sui social network. Una casa editrice che rappresenta davvero un unicum nella realtà editoriale napoletana e che farà ancora tanta strada».
Con questo libro il nuovo corso letterario di Marco Perillo?
«Sicuramente è la chiusura di un cerchio. Perché, come diceva Nietzsche, i miei scritti sono i miei superamenti. In molti scopriranno un Marco Perillo nuovo, diverso, forse inaspettato. Senz’altro più maturo, poiché quel che mi preme, più del racconto della città e dei suoi fenomeni, è quello della sua umanità attraverso i personaggi. C’è introspezione psicologica, oltre all’indagine sociale. C’è la forte motivazione dell’anima, insieme con l’azione. Perché solo attraverso la narrativa – e non tanto attraverso la saggistica o il giornalismo – si possono comprendere a fondo e raccontare certe realtà. Perché abbiamo a che fare con l’umanità e con la sua complessità. Ci ho preso gusto e non escludo possa accadere ancora».
–
Sostienici: acquista questo titolo cliccando direttamente sul link sottostante









