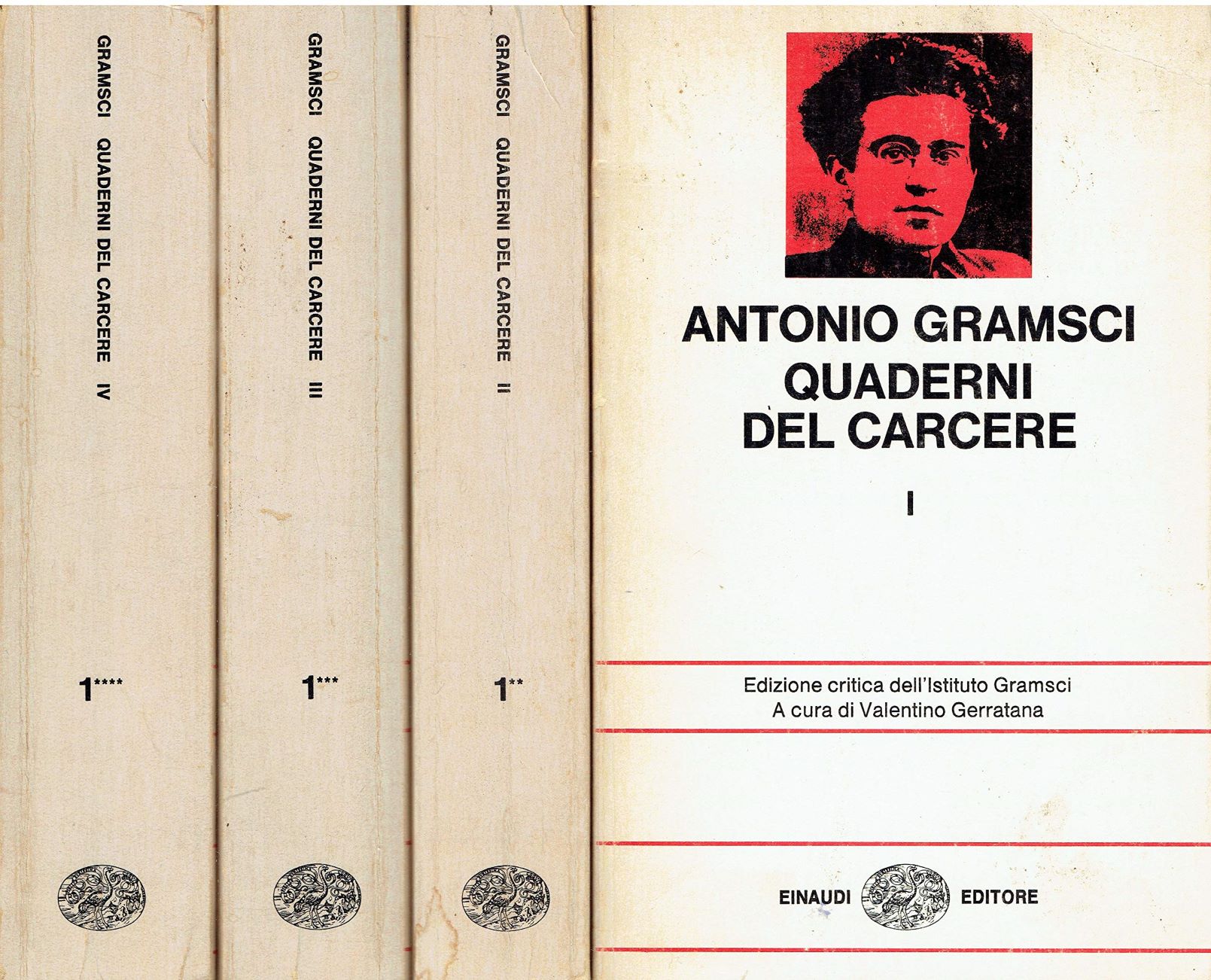Sono trascorsi trent’anni da quel 23 maggio del 1992. Trenta come le commemorazioni che, nel tempo, si sono susseguite per omaggiare Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro, le vittime di Capaci, i martiri di un attentato rivendicato dalla mafia ma firmato anche dallo Stato italiano.
Trent’anni di mezze verità, di storie raccontate per compiacere, di film e serie tv, di trasmissioni e articoli di giornale, di marce per non dimenticare, fotografie idolatrate come santini, uomini di legge diventati eroi soltanto perché morti, per molti imprenditori di se stessi mentre ancora erano in vita.
Trent’anni in cui in Italia siamo stati capaci di ricordare, ma sempre incapaci di cambiare. Vittime, anche noi, di una strage che non abbiamo impedito, che ancora ci portiamo dentro, che forse non smetteremo mai di sentire nostra perché nostra è la terra malata, nostra la colpa, nostra la mala politica, nostra quella cosa che dà il nome all’organizzazione criminale di Totò Riina, il Capo dei Capi, il detenuto a cui avremmo concesso di morire a casa e non in ospedale, mentre preferiamo togliere le scorte ai magistrati e ai giornalisti minacciati dai discepoli del boss per eccellenza.
Trent’anni in cui lo Stato in qualche modo si è estinto, scomparso a poco a poco, e con esso la fiducia nelle istituzioni dei cittadini perbene, persone spaventate e disincantate, assuefatte ormai dall’idea che la criminalità organizzata abiti i palazzi che contano, vesta giacca e cravatta, si candidi alle elezioni e le vinca pure, muova i fili di un Paese perseguitato da se stesso e dai propri fantasmi sempre vivi.
Trent’anni da quei cinquantasette giorni che separarono Capaci da via D’Amelio, Falcone da Borsellino, da un’altra strage annunciata, da un altro ricordo, da un rumore assordante di allarmi e sirene, dal boato di un pomeriggio d’estate, dal silenzio di una morte prevista, da un’altra farsa all’italiana. Soltanto tre anni prima, il 21 giugno 1989, c’era stato il mancato attentato dell’Addaura, ma persino nelle stanze della DC e del PCI palermitane – accuserà Gerardo Chiaromonte, futuro Presidente della Commissione Antimafia –, si sosteneva che fosse stato lo stesso Falcone a organizzare il tutto per farsi pubblicità. Il tutto erano 58 cartucce di esplosivo ritrovate alle 7:30 del mattino dagli agenti di polizia a pochi metri da loro e dal giudice. «Questo è un Paese felice in cui se ti si pone una bomba sotto casa e la bomba per fortuna non esplode, la colpa è tua che non l’hai fatta esplodere», rispose Falcone alle accuse.
Che sarebbero morti lo sapevano tutti, anche loro, ma nessuno si era preoccupato seriamente di proteggerli, così come nessuno si è poi preoccupato di portarne avanti la battaglia, magari negli stessi modi e toni, di lanciare un messaggio chiaro alla mafia: noi non abbiamo paura, l’Italia non ne ha, lo Stato sa chi siete e vi verrà a prendere, a uno a uno, fino a vedervi sparire. Con lo sparire, invece, ha finito ogni ricerca di verità, di un nome che rispondesse a un responsabile piuttosto che a un’entità, a un’associazione che altro non è che un gruppo di uomini e, in quanto tale, direbbe il giudice, come tutti i fatti umani ha un inizio e una fine, non può non averne. Addirittura, sono stati assolti alcuni degli imputati, un’agenda rossa si è fatta leggenda, la mafia non è morta, Falcone e Borsellino sì.
Milletrecentosessantotto ore, ottantaduemilaottanta minuti. È il tempo trascorso tra le 18:08 del 23 maggio e le 16:58 del 19 luglio, il tempo che è bastato a chiarire chi comandava allora e chi comanda oggi, chi comanderà sempre finché saremo capaci di ricordare, ma incapaci di cambiare. Collusi anche noi, tutti, quando per trent’anni abbiamo lasciato che al potere si susseguissero, senza tuttavia mai lasciarsi il posto reciprocamente, individui fin troppo spesso associati a quella mafia che Silvio Berlusconi attribuisce a La piovra e Matteo Salvini si dichiara in grado di sconfiggere in pochi mesi. Entrambi, però, ben attenti a tenerla silenziosamente lì, viva più che mai, Marcello Dell’Utri a fare ancora da garante.
Sono trascorsi trent’anni da quel 23 maggio del 1992. Dell’antimafia non vi è nemmeno più l’ombra. Molti slogan e qualche foto, magari in divisa, per fare clamore senza disturbare, un’opposizione blanda che ci fa persino sorridere e, invece, dovrebbe trasformarsi in molla, in reazione, in una commemorazione che è militanza, presa di coscienza, reazione. Nemmeno le bombe sono bastate. È così, dunque, che deve finire? È per questo che Giovanni Falcone e Paolo Borsellino si sono fatti ammazzare? Per lasciare campo libero a noi, ai nostri aguzzini, ai padrini dell’Italia? Perché, allora, una volta per tutte, non smettiamo di ricordare? Piangiamo Riina e Provenzano piuttosto, spediamo qualche sigaretta pure a Raffaele Cutolo, ma lasciamo stare i morti buoni, i magistrati, i giudici, le scorte, gli innocenti.
Abbattiamo quel grosso albero di Palermo, votiamo i neofascisti, dimentichiamo che non hanno mai risposto alle domande disintegratesi a Capaci: «È a conoscenza di qualche fatto o circostanza che potrebbe far luce sull’uccisione di Mattarella?», Falcone indagava sulla scomparsa di Piersanti, il fratello dell’attuale Presidente della Repubblica. Il quesito era per il leader di una forza che oggi si definisce nuova e, invece, è antica come le metastasi che condannano l’Italia. Come quel giovane Totò Cuffaro che si scagliò contro l’antimafia in diretta tv perché, per lui, era in atto una volgare aggressione alla classe dirigente migliore che abbia avuto la Democrazia Cristiana sull’isola. Tra i fischi della gente, un bel po’ di anni prima di diventare Presidente della Regione e finire in galera per favoreggiamento personale a persone appartenenti a Cosa Nostra, parlò addirittura di giornalismo mafioso che, a suo dire, fa più male alla Sicilia di dieci anni di delitti. Non a caso, frasi che ancora oggi, in politica, risuonano forte in altre sedi, in altri dialetti, in altre bocche, amare come il sangue di chi si è fatto martire.
A colei che gli chiese da chi fosse protetto, visto che era fortunatamente ancora tra noi, Giovanni Falcone domandò, forse più a se stesso che all’interlocutrice, se per essere credibili, in questo Paese, bisogna essere ammazzati. Trent’anni dopo, tuttavia, sebbene quel presagio si sia avverato, resta difficile dargli una risposta sincera. Per noi, si intende, che piangendo ai funerali, abbiamo poi finito con l’ucciderlo ripetutamente. Forse, aveva ragione Paolo Borsellino parlando dell’amico e collega: era un testa di minchia. Proprio come lui, uno che aveva sognato niente di meno di sconfiggere la mafia applicando la legge. In Italia, poi, dove tutti siamo capaci di ricordare, ma incapaci di cambiare.